Egoismo e indifferenza si superano riscoprendo il fondamento dell’autorità politica
di Don Gian Maria Comolli*
–
DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA COME PROGETTO PER RIFORMARE LA SOCIETÀ
L’autorità, in politica, si fonda sulla natura sociale dell’uomo, ed è essenziale e insostituibile per edificare una vita civile strutturata, ordinata e giusta. Le formalità possono essere eterogenee in base alle condizioni storiche e culturali, poiché non è la forma che garantisce la validità di una metodologia ma i valori di riferimento. Infatti, come ricorda il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa (2 aprile 2004), l’esercizio dell’autorità politica «sia nella comunità come tale, sia negli organismi che rappresentano lo stato, deve sempre essere praticato entro i limiti dell’ordine morale, per procurare il bene comune – concepito però dinamicamente – secondo un ordinamento giuridico legittimamente definito o da definire. Allora i cittadini sono obbligati in coscienza ad obbedire» (n. 394).
Soggetto dell’autorità politica, cioè chi sceglie l’autorità e ne verifica l’operato, è il popolo «considerato nella sua totalità quale detentore della sovranità. Il popolo, in varie forme, trasferisce l’esercizio della sua sovranità a coloro che liberamente elegge suoi rappresentanti, ma conserva la facoltà di farla valere nel controllo dell’operato dei governanti e anche nella loro sostituzione, qualora essi non adempiano in maniera soddisfacente alle loro funzioni» (n. 395).
Questa “responsabilità del popolo”, spesso poco percepita, dovrebbe investire due soggetti. Da una parte i partiti e movimenti politici, gli intermediari dei cittadini presso le Istituzioni, che negli ultimi decenni hanno però perso molta credibilità, mostrando l’inadeguatezza ad affrontare le sfide contemporanee anche a causa delle pressioni provenienti dalle veloci trasformazioni, della globalizzazione e dai mercati globali. Ciò è avvenuto, perdendo i partiti con il trascorrere del tempo, persone attendibili, qualificate e autorevoli, cioè con una profonda formazione interiore, professionale ed etica capaci di interpretare gli eventi, proporre strategie, trasmettere idee innovative e aprire nuove vie. Dall’altra, il crescente disinteresse dei cittadini nei riguardi della politica, che si manifesta nella indisponibilità all’impegno civico di occupare gli spazi che la democrazia offre.

Altro sintomo preoccupante è la partecipazione elettorale in continuo calo, sintomo della crisi della democrazia rappresentativa di molti Paesi, dove gli interessi dei rappresentanti non si specchiano più nelle attese dei rappresentati.
Il Compendio propone un concetto classico di autorità che trae la dignità e la forza nell’ordine morale, «il quale si fonda in Dio, che ne è il primo principio e l’ultimo fine» (Pio XII, Messaggio natalizio, 24 dicembre 1945). Di conseguenza, l’autorità deve riconoscere, rispettare e promuovere i valori umani e morali essenziali; «valori, pertanto, che nessun individuo, nessuna maggioranza e nessuno Stato potranno mai creare, modificare o distruggere» (n. 397).
È questo un chiaro rifiuto della concezione filosofica-politica diffusa prevalentemente nei Paesi anglosassoni, definita “contrattualista”. Il contrattualismo, che trovò in Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) i maggiori esponenti, comprende quelle teorie politiche che definiscono la società “un contratto” tra governanti e cittadini, affermando, di conseguenza, che lo Stato si fonda sulla stipula di un accordo fra gli individui basato sulle opinioni provvisorie e mutevoli della maggioranza. Di conseguenza, nessuna verità soggettiva, può precedere e superare il consenso democratico o l’assenso di una prevalenza numerica. Inoltre, l’autorità, deve emanare leggi giuste, cioè conformi alla dignità della persona umana e ai dettami della retta ragione.

Quando le leggi della comunità civile ledono l’ordine morale naturale, sono normative ingiuste che “non obbligano in coscienza”, come affermato da san Tommaso d’Aquino: «una legge ingiusta non è una legge» (“lex iniusta, nulla lex”, Summa Teologica, I-II, q.96, a.4).
Allorché una legge è incompatibile con le valenze etiche e divergente dai diritti fondamentali della persona, dal bene comune, dalle convinzioni religiose e morali del singolo, non obbliga in coscienza, esorbitando questi fattori dal potere dello Stato. È quindi doveroso porre in atto l’obiezione di coscienza. E «chi ricorre all’obiezione di coscienza deve essere salvaguardato non solo da sanzioni penali, ma anche da qualsiasi danno sul piano legale, disciplinare, economico e professionale» (Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, 25 marzo 1995, n. 74). Serve chiarire che l’obiezione di coscienza non costituisce, come alcuni ritengono, una benevola concessione dello Stato, bensì è “un diritto” che una Nazione dove vige la democrazia deve attuare distinguendosi dai Paesi governati dalle dittature o dai totalitarismi. Inoltre, vari documenti internazionali, ne evidenziano l’obbligatorietà. Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo del 1948 (cfr. gli articoli 1, 3 e 18) e nel Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (trattato internazionale vincolante per gli Stati che l’hanno sottoscritto, fra i quali l’Italia), l’obiezione di coscienza è riconosciuta come un “diritto inderogabile” che i Governi devono sempre rispettare, anche in circostanze di emergenza pubblica.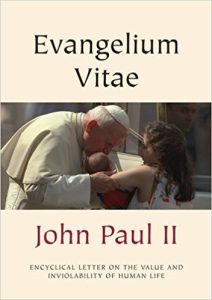
Oltre all’obiezione di coscienza la Dottrina sociale della Chiesa propone il diritto di resistenza all’autorità, qualora questa violi in modo grave e ripetuto i principi del diritto naturale. Di fronte a tirannie, pur essendo suggerita e raccomandata la resistenza passiva, più conforme ai principi morali e non meno promettente di successo, il Compendio non esclude questo diritto normato dai chiari criteri presenti enucleati dal Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC). «La resistenza all’oppressione del potere politico – afferma il CCC – non ricorrerà legittimamente alle armi, salvo quando sussistano tutte insieme le seguenti condizioni: 1. in caso di violazioni certe, gravi e prolungate dei diritti fondamentali; 2. dopo che si siano tentate tutte le altre vie; 3. senza che si provochino disordini peggiori; 4. qualora vi sia una fondata speranza di successo; 5. se è impossibile intravedere ragionevolmente soluzioni migliori» (n. 2243).
Per tutelare il bene comune, quando si evidenziano comportamenti dannosi al diritto degli altri, lo Stato, mediante il potere giudiziario esercitato dalla Magistratura, ha il dovere di comminare pene proporzionate ai delitti. Ogni pena, ricorda il Compendio, «non serve unicamente allo scopo di difendere l’ordine pubblico e di garantire la sicurezza delle persone: essa diventa, altresì, uno strumento per la correzione del colpevole, una correzione che assume anche il valore morale di espiazione» (n. 403). Ebbene, correzione ed espiazione, non possono assumere il significato di vendetta ma quello di redenzione del colpevole. Chi ha commesso reati sono uomini e donne che stanno espiando con la “perdita della libertà” i loro errori ma non hanno smarrito la loro “dignità di persona”, anche se oggi, molti, vivono questo periodo, in luoghi sovraffollati, irrispettosi dei loro diritti e privi di umanità. Quindi, non in ambienti preventivi, educativi e redentivi ma in situazioni altamente diseducative e, a volte, moltiplicatrici di delinquenza. Gli sbagli perpetrati suscitano sentimenti di fallimento e sensazioni d’impotenza; perciò, va valorizzata la dignità di ogni prigioniero, infondendogli fiducia e ricordargli che al di là delle devianze, hanno delle potenzialità da risvegliare potendo sempre ricominciare, poiché il periodo del carcere è transitorio.

Il Compendio al numero 404 evidenzia le modalità da adottare per investigare sulla verità che riassume nella frase: «pieno rispetto della dignità e dei diritti della persona umana». Ciò significa chi è accusato di un reato è innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. In concreto, il presupposto di innocenza, richiede determinati comportamenti nell’espletamento dell’indagine. Il giusto uso della detenzione preventiva che non può essere motivata dal tentativo di ottenere notizie significative per il processo; l’esclusione di ogni pratica di tortura fisica o psicologica; la celerità dei processi; l’osservanza da parte dell’autorità indagante del massimo riserbo e riservatezza. E, da ultimo, «poiché anche un giudice può sbagliarsi, è opportuno che la legislazione disponga un equo indennizzo per la vittima di un errore giudiziario» (n. 404).
In conclusione, il Compendio vede positivamente l’avversione dell’opinione pubblica alla pena di morte, poiché il criminale può essere reso inoffensivo senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi (cfr. n. 405).
—-
*sacerdote ambrosiano, collaboratore dell’Ufficio della Pastorale della Salute dell’arcidiocesi di Milano e segretario della Consulta per la Pastorale della Salute della Regione Lombardia. Cura il blog: www.gianmariacomolli.it.




