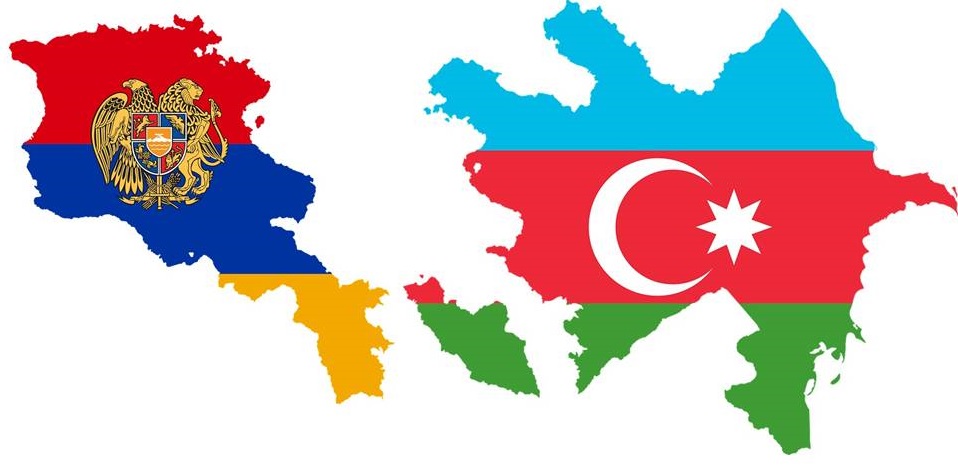Foibe, esodo, confini nordorientali d’Italia: parla l’esule Denis Zigante
di Matteo Orlando
–
ZIGANTE: “TITO AMBIVA AD UNA CONQUISTA ESTESA ALMENO FINO A TRIESTE E GORIZIA (E ALLE LORO PROVINCE) E ALL’ELIMINAZIONE, CON OGNI MEZZO, DELL’ELEMENTO ITALIANO, DIVENUTO UN OSTACOLO PERICOLOSO E PESANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SLAVO-COMUNISTA”
“Di foibe e di esodo non si doveva parlare, come del fatto che l’Italia pagò i danni di guerra alla Jugoslavia con i beni abbandonati dagli esuli, per i quali i previsti equi indennizzi ora, oltre la terza generazione dopo i fatti, ancora non sono del tutto liquidati. Era la ragion di stato, per la quale spesso le vittime diventano carnefici e viceversa. Tito era diventato il capo dei paesi non allineati, utile nella politica mondiale, e l’Italia aveva il più forte partito comunista dell’Occidente, motivi per cui la strada della verità era preclusa”. A dirlo in questa intervista è Denis Zigante, un esule nato ad Umago il 19 settembre del 1956.
Umago, allora, era situata nella zona B (parte istriana fino al fiume Quieto in amministrazione jugoslava) del territorio libero di Trieste previsto, e mai istituito, dall’articolo 21 del Trattato di Pace di Parigi del 1947 che, nella zona A comprendeva la città di Trieste.
Profugo dall’Istria nel 1963, con genitori e sorella, Denis Zigante fu ospitato in Italia in più campi profughi: Risiera di San Sabba a Trieste (negli anni Settanta divenuto monumento nazionale come unico campo di concentramento nazista in Italia), Capua, provincia di Caserta e Tortona, provincia di Alessandria. Stabilitosi con la famiglia a Trieste ci vive ancora pensionato delle Poste Italiane e nonno di due nipotini.
Zigante, dal 1992 al 1998, è stato Presidente dell’Unione degli Istriani di Trieste, una delle maggiori associazioni di esuli istriani, fiumani e dalmati. In questa veste, oltre alla attività statutaria di conservazione e divulgazione degli ideali e della memoria del popolo istriano, è stato promotore ed editore di numerose pubblicazioni: libri di narrativa e poesia, saggi storici, stampa periodica, il tutto sul tema foibe ed esodo e problematiche connesse. Di particolare rilevanza storico-scientifica è il volume ” Albo d’oro – La Venezia Giulia e la Dalmazia nell’ultimo conflitto mondiale” di Luigi Papo De Montana, nel quale si pubblicano, tra importanti notazioni storiche, gli elenchi e le circostanze di tutti i caduti e dispersi giuliano dalmati nei vari teatri di guerra del secondo conflitto mondiale.

Zigante, dal 1997 al 1998, è stato Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati che raggruppa tutte le associazioni: L’Unione degli Istriani, L’Associazione delle Comunità Istriane, L’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, II Libero Comune di Pola in esilio, Il Libero Comune di Fiume in esilio, Il Libero Comune di Zara in esilio. In tale veste è stato promotore del raduno mondiale degli esuli giuliano-dalmati tenutosi a Trieste il 13 e 14 settembre 1997, in occasione del cinquantesimo anniversario del Trattato di Parigi. In seguito al raduno ha ottenuto l’emissione di un francobollo commemorativo da parte di Poste Italiane in 3,5 milioni di esemplari da 800 Lire di valore e raffigurante “La poppa della motonave ” Toscana”, che nel ’47 trasportava gli esuli e le loro masserizie da Pola a Venezia, con bandiera tricolore e la scritta “L’esodo degli Italiani dall’Istria Fiume e Dalmazia”.
Zigante nel 1998 ha guidato una nutrita delegazione di dirigenti dell’associazionismo esule in udienza presso il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro a perorare la propria causa presso la patria italiana e la richiesta di un intervento presso il Ministero della Pubblica Istruzione per una maggior presenza di foibe ed esodo nei libri di testo. Negli anni successivi ha presenziato a numerosi incontri e convegni, anche con scolaresche, a Roma, Torino, Osimo, Modena, Rovereto, Genova e presso la televisione italiana della Svizzera a Lugano.
Quali erano i confini italiani negli anni Quaranta del secolo scorso?
La storia si compone di due dimensioni: il tempo e il luogo. Relativamente a questi aspetti diremo che i confini nordorientali d’Italia negli anni 40 del ‘900, sotto il profilo politico, erano stati stabiliti alla fine del primo conflitto mondiale dal Trattato di Versailles del 1919 e dal Trattato di Rapallo del 1920, quest’ultimo tenutosi essendo conclusa con il cosiddetto Natale di sangue l’impresa dannunziana di Fiume. Dal punto di vista, invece, della geografia fisica focalizziamo il territorio di cui parliamo in quella penisola di forma triangolare, con il vertice in basso, posta a sud di Trieste, la penisola istriana, a cui vanno aggiunte alcune isole e località della Dalmazia ancora più meridionali rispetto all’Istria, a parte le isole di Cherso e Lussino, dette località costituivano in quegli anni delle enclave nel nuovo regno degli slavi del sud, cioè Regno di Jugoslavia. In conclusione diremo che la provincia di Gorizia, quella di Trieste, quella di Fiume, quella di Pola, quindi tutta l’Istria, con le isole di Cherso e Lussino e la città dalmatica di Zara con la sua provincia, erano le componenti territoriali della Venezia Giulia, esclusa Zara ovviamente, dagli anni 20 del 900 al 1945. Quella Venezia Giulia, la cui denominazione nacque dalla proposta del glottologo goriziano Graziadio Ascoli nel 1863, quella Venezia Giulia dunque che, anche se solo de iure ma non de facto, in certi momenti, costituì i confini nordorientali d’Italia negli anni quaranta del secolo scorso. Fiume, Pola, Zara e le citate isole sono oggi parte della Repubblica di Croazia, la quale fino al 1991 componeva con altre cinque Repubbliche la Repubblica Federativa di Jugoslavia.
Ci può raccontare in breve la storia istriano-giuliano dalmata?
I territori giuliano-dalmati di cui parliamo comprendevano le aree del goriziano, della Tergestum, ovvero Trieste, dell’Istria e, passando per Fiume, delle fasce litoranee ed insulari della Dalmazia fino a Ragusa, l’odierna Dubrovnik, a ridosso delle Bocche di Cattaro, oggi in Montenegro. I primi insediamenti preistorici, dell’età del bronzo, furono caratterizzati dalla civiltà dei castellieri per poi evidenziarsi con la presenza del popolo degli Istri, nella parte più settentrionale, e degli Illiri verso la Dalmazia che, per l’appunto, fu chiamata anche Illiria. Conquistati da Roma i territori giuliano-dalmati furono parte della Decima Regio romana, con capitale Aquileia. Questa fu pure sede di un importante patriarcato della chiesa cattolica dal secondo secolo dopo Cristo al luglio 1751 quando fu soppressa. L’importanza di questa istituzione cattolica, titolare pure di possedimenti territoriali, è intuibile se si pensa che quei territori furono la porta d’ingresso di gran parte delle invasioni barbariche prima e dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Da segnalare l’arrivo intorno al sesto secolo dopo Cristo della popolazione degli sloveni che erano, diciamo, gli addetti alle salmerie di un popolo più numeroso e bellicoso, gli Avari, e che si stanziarono nei territori interni della Venezia Giulia, fino alla odierna Lubiana, senza mai affacciarsi al mare. Intanto era nata la città di Venezia e alla sua crescente potenza internazionale, la Venezia Giulia si sottomise, con diverse modalità e tempistiche, con tutte le sue città marine e terrestri. Fino al 17 ottobre 1797, giorno del Trattato di Campoformido (in veneto Campoformio) con cui Napoleone Bonaparte consegnava la Repubblica di Venezia, insieme all’Istria e alla Dalmazia, all’Arciducato d’Austria. Si dovette aspettare fino al 1918, cioè fino alla conclusione della prima guerra mondiale, definita anche come la Quarta Guerra d’Indipendenza proprio perché aveva nel proprio impeto ideale il ritorno all’Italia di Trento e Trieste e, di conseguenza, della Venezia Giulia e della Dalmazia. Questa situazione di sovranità territoriale durò fino al 10 febbraio 1947, giorno della firma del Trattato di Parigi, da molti definito diktat, che pose fine alla seconda guerra mondiale e stabilì il nuovo assetto geopolitico europeo e mondiale nel quale i territori giuliano-dalmati si videro tragicamente menomati. Da ultimo in questo breve excursus storico sulle vicende antiche e moderne dell’Istria, Fiume e Dalmazia, mi preme sottolineare un aspetto che sarà importante nel prosieguo di questa trattazione: l’italianità delle terre giuliano-dalmate. Già nel 1300 Dante Alighieri ebbe a scrivere nel canto IX dell’Inferno: ”Si com’a Pola, presso del Carnaro ch’Italia chiude e i suoi termini bagna”, con ciò affermando, dunque, che Istria e Fiume, bagnate dal Golfo del Quarnaro, erano gli estremi confini nordorientali d’Italia.

Quali erano gli intenti del maresciallo Tito e cosa voleva creare in quei territori?
Il Maresciallo Josip Broz, detto Tito, nato in Croazia, in territorio dell’Impero austro ungarico, fu sergente del relativo esercito nella I guerra mondiale e fu fatto prigioniero dai Russi. Per anni visse e si formò al cospetto dei Bolscevichi portando poi la loro ideologia e fondando il Partito Comunista in Jugoslavia. Allo scoppio della II guerra mondiale e dopo l’occupazione nazista, divenne il Capo del MPL (Movimento Popolare di Liberazione) e della politica di questo fu il massimo ideatore e fautore. Forte di questa posizione di vertice, per rispondere alla domanda su cosa voleva creare nei territori giuliano-dalmati, Tito diventò l’incarnazione della politica jugoslava portata avanti durante e dopo l’ultimo conflitto mondiale, politica che si poteva individuare in due obiettivi principali: a breve termine una salda presa di possesso militare e politica dei territori abbandonati dalle forze naziste in ritirata, territori, ricordiamolo, appartenenti all’Italia fino a quel momento, e un altro, a medio e, se necessario, a lungo termine, che consisteva nella pulizia etnica su quelle terre. Questa inumana pratica che prevede la rimozione forzata di una minoranza etnico culturale per conservare e proteggere l’identità di una determinata popolazione, in Istria e Dalmazia fu ancora, se possibile, più feroce se si pensa che si attivò nei confronti di quella che era storicamente la maggioranza della gente autoctona. Si può dire, quindi, che il Maresciallo Tito approfittò della guerra per imporre un’ideologia politica utile al suo disegno di unificazione dei popoli slavi, di cui lui sarebbe diventato l’elemento dominante attraverso lo strumento del partito, e di una ideologia etnica che faceva leva sull’orgoglio nazionale croato e sul desiderio del ricongiungimento delle popolazioni croate alla Madre Patria. Il problema non era costituito da normali aspirazioni nazionali ma dal fatto che queste aspirazioni si basavano su antistoriche e deliranti teorie che prevedevano addirittura una slavia veneta. Da ciò si capisce come Tito ambiva ad una conquista estesa almeno fino a Trieste e Gorizia e alle loro province e all’eliminazione, con ogni mezzo, dell’elemento italiano, divenuto un ostacolo pericoloso e pesante per la realizzazione del programma slavo-comunista.
Ci può parlare dello strumento della pulizia etnica utilizzato dagli slavi?
Abbiamo visto quali erano le mire del Maresciallo Tito per i territori istro-dalmati Queste mire andavano al di là della semplice vittoria sul nemico nazi-fascista e il predominio assoluto del partito e della ideologia comunista. Esse comprendevano l’ineludibile necessità di conquistare tutta la Venezia Giulia per farne, a guerra finita, la settima Repubblica dell’agognata e prevista Repubblica Federativa di Jugoslavia. Prova di ciò è stata la grande ostilità, fino all’eliminazione fisica, degli elementi, diciamo, filoitaliani in seno al movimento partigiano di liberazione. In altre parole: chi si impegnava nella guerra per la sconfitta del nemico e il ritorno alla libertà ma non vedeva né, tantomeno, desiderava una conquista slavo-comunista della Venezia Giulia, veniva osteggiato ed eliminato. Ricordiamo, in ordine a questo tema, l’eccidio perpetrato nel febbraio del 1945 ai danni delle Brigate Osoppo, formazioni di orientamento cattolico e laico-socialista, presso Porzus, in provincia di Udine. L’eccidio fu commesso da un gruppo di partigiani comunisti italiani dei Gruppi di Azione Partigiana (GAP) in stretto contatto con il IX Corpus partigiano di Tito. Appare evidente come, al di là della guerra e, ovviamente della vittoria, alle mire annessionistiche di Tito serviva un ambiente politico ed umano diverso da quello esistente, un ambiente, cioè, privo dell’elemento italiano. E per ottenerlo bisognava mettere in pratica quella che con termine moderno, è stata definita: ”pulizia etnica”. Tale pratica necessitava di due azioni concrete: l’eliminazione fisica e l’allontanamento dei portatori di italianità. Al primo caso si diede il nome onnicomprensivo ed emblematico di FOIBE, al secondo quello di ESODO.

Cosa sono state le foibe?
Il nome FOIBA deriva dal latino “FOVEA” che significa fossa, cava. Ed è il nome dato ai circa 1700 inghiottitoi a forma di caverne verticali e pozzi, tipici della regione carsica e dell’Istria. Sono voragini scavate per erosione idrica a forma di imbuto rovesciato profonde fino a duecento metri. E “TRAGICA STAGIONE DELLE FOIBE” è il nome che fu dato al periodo e ai fatti accaduti in Istria dopo l’8 settembre 1943, il giorno dell’armistizio. Quel giorno che fu la notte per la nazione italiana, il giorno in cui gli Italiani furono lasciati soli con sé stessi, senza guida ne’ indicazioni. In Istria, Fiume e Dalmazia iniziarono i quasi due mesi di caccia al fascista o al semplice funzionario o impiegato pubblico o insegnante, al sacerdote, al compromesso col regime, all’avversario politico ma, anche al semplice conoscente, vicino di casa, più bravo o fortunato di altri nella professione. In una parola: caccia all’Italiano solo perché tale. Fu una eliminazione basata su delazioni e denunce, spesso anonime. Eliminazioni compiute nottetempo per le quali, spesso, dopo brutali torture e indicibili sevizie, si usarono le cavità carsiche suddette ma anche pozzi di miniera o cave di bauxite. Il secondo tempo del capitolo FOIBE si ebbe a Trieste e la sua provincia e a Gorizia e la sua provincia nei quaranta giorni dell’occupazione slava, dal primo maggio 1945 al 12 giugno 1945. Da notare che la liberazione italiana si compì il 25 aprile 1945 e che quindi i fatti di questa narrazione furono successivi alla fine della guerra. Il IX Corpus delle truppe partigiane di Tito occupò il capoluogo giuliano prima degli alleati neozelandesi, che ebbero un colpevole ritardo, e istituì il governo del popolo con relativo Tribunale. Da qui iniziò l’opera di rastrellamento e sparizione di uomini e donne giudicati nemici del popolo ed eliminati o internati in campi di concentramento perché avversari politici ma, soprattutto, perché Italiani. Per dare una dimensione alla vicenda FOIBE prendiamo alcuni dati dall’ Albo D’oro – La Venezia Giulia e la Dalmazia – Nell’Ultimo Conflitto Mondiale – di Luigi Papo de Montona, seconda edizione dell’Unione degli Istriani di Trieste. Salme esumate 994, vittime accertate ma non trovate 326, vittime presunte 5643, vittime nei campi di concentramento jugoslavi 3174. Inoltre: sono state 117 le foibe, fosse, miniere, grotte, abissi, cave, specchi di mare, luoghi in genere censiti come teatro degli eccidi denominati delle foibe. Di questi 61 sono vere e proprie foibe. In 37 casi di quei 117 non è stato possibile nessun accertamento pur essendo notorio che lì furono compiuti altri massacri.
Ci parla dell’esodo di quelle popolazioni italiane verso la penisola e del suo in particolare?
Abbiamo visto come la politica annessionista di Tito verso le terre giuliano-dalmate aveva bisogno non solo della vittoria sul nazifascismo ma pure del sostegno di una realtà civile che fosse il più possibile slava o almeno il più possibile affine in senso ideologico, cioè comunista. Per ottenere un tale stato di cose egli si dedicò alla pulizia etnica ante litteram usando l’elemento terrore e foibe per ottenere l’altro elemento costituente: la fuga della popolazione, cioè l’ ESODO. Nel 1996, Milovan Gilas, braccio destro di Tito, dichiarò che lui e l’altro braccio destro, Edvard Kardely, fin dal 1942 giravano clandestinamente l’Istria per stilare elenchi di persone compromesse e, dunque, eliminabili. È chiaro che non si trattava solo, o non solo, di dipendenti pubblici, insegnanti, pubblici esercenti, religiosi, questi si conoscevano, ma anche di persone appartenenti ad altre associazioni o circoli come la Lega Nazionale o la Dante Alighieri o ad altri sodalizi ancora, di base ideale e culturale italiana. Tito ed i suoi seguaci profusero ogni sforzo, fisico e psicologico, per creare nella Venezia Giulia un clima in cui un Italiano, angosciato per la sorte sua e dei suoi famigliari, potesse immaginare di vivere a lungo. Della sanguinosa tragedia delle foibe abbiamo detto. Ad essa vanno aggiunte quotidiane intimidazioni e minacce e terribili fatti di sangue come la strage di Vergarolla. A guerra finita e in occupazione alleata, il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, vicino a Pola, durante una manifestazione sportiva, mani ignote fecero esplodere del materiale bellico, come mine navali, lì accatastato, causando 65 morti, molte decine di feriti e 5 dispersi. Ecco, quindi, l’ESODO. Si può ragionevolmente dire che quel giorno cominciò l’esodo dei giuliani-dalmati. E Pola ne fu la massima rappresentazione: da quel giorno e dopo il 10 febbraio 1947, quando si capì che per l’Istria e Dalmazia non c’era più nulla da fare, da Pola se ne andarono 32.000 abitanti su 34.000. Il 95% della popolazione di nazionalità italiana se ne andò. Durante il periodo bellico, dopo Parigi 1947, dopo il Memorandum di Londra del 1954 e, ancora, negli anni sessanta, furono 35.000 che se ne andarono. Quasi i due terzi degli abitanti di Istria Fiume e Dalmazia italiana secondo il censimento del 1936. Dell’esodo e dei suoi attori si potrebbe dire a lungo. Non avendo tutto questo tempo e solo perché richiesto, mi limiterò ad accennare al mio esodo, cioè di mio padre e di mia madre con me e mia sorella. Mio padre Simone avrebbe voluto e potuto esodare già nel 1949, in quanto “optante”, avendo cioè scelto l’Italia in base al diritto di opzione che gli abitanti dell’Istria avevano avuto in forza del trattato di pace. Il governo croato non glielo permise, non poterono fuoriuscire né lui né sua moglie, cioè mia madre. Appena ottenuto il passaporto jugoslavo, quattordici anni dopo, Simone, prima lui e una settimana dopo la famiglia cioè mia madre, io e mia sorella, per non dare nell’ occhio, lasciò Cittanova d’Istria e quel poco che aveva e venne a Trieste. Chiese asilo politico in quanto optante e fu sistemato per la quarantena presso la Risiera di San Sabba di Trieste, oggi monumento nazionale in quanto unico campo di concentramento nazista in Italia, ma allora non si sapeva. Da lì siamo stati trasferiti al campo profughi di Capua, in provincia di Caserta, per un anno. Poi a Tortona, provincia di Alessandria, per tre mesi. Poi, grazie ad una “garanzia” firmata dalla sorella di mia madre, ritorno definitivo a Trieste a cercare alloggio e lavoro per vivere.
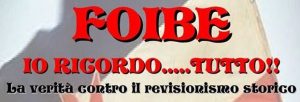
Come sono stati accolti gli esuli istriano-giuliano-dalmati sulla penisola?
L’ esodo dei 350.000 Giuliano-Dalmati si compì in circa 20 anni, dalla metà degli anni 40 alla metà degli anni 60. Gli esuli furono sistemati in ben 109 campi profughi sparsi su tutto il territorio italiano dal Piemonte alla Sicilia. Molti da lì emigrarono in Australia, Nord America, Argentina ed Europa, molti rimasero o tornarono a Trieste e in Friuli Venezia Giulia, molti vissero nei campi profughi per poi stabilirsi nelle stesse località dove furono costruiti anche interi quartieri urbani per la loro sistemazione. La più conosciuta e singolare di queste sistemazioni fu la cittadina di Fertilia, vicina ad Alghero, costruita negli anni 30 ma popolata dal primo nucleo di 600 esuli giuliano-dalmati nei primi anni 50. Il grande problema e la nota dolente dei rapporti della vittima della tragedia delle foibe e protagonista dell’esodo, cioè il popolo giuliano-dalmata, con la madre patria italiana, non stanno in ciò che essa riuscì a dare alla nostra gente, ma in quello che essa non seppe o non volle riconoscere e proteggere, cioè il suo amor patrio e il bisogno di giustizia. L’Italia non protesse l’Istria né durante la guerra, né dopo. Non lo fece né politicamente né culturalmente. Non ottenne né un plebiscito né si impose in alcun modo alle mutilazioni territoriali imposte dalle Commissioni alleate totalmente filo jugoslave. Permise che nell’immaginario collettivo mondiale l’esodo fosse visto come la fuga di fascisti dalla modernità socialista. Tant’è vero che, ad esempio, nella stazione ferroviaria di Bologna si organizzarono scioperi per non dare assistenza, né acqua, ai vagoni di fascisti che scappavano dal Paradiso dell’autogestione jugoslava. Di foibe e di esodo non si doveva parlare, come del fatto che l’Italia pagò i danni di guerra alla Jugoslavia con i beni abbandonati dagli esuli, per i quali i previsti equi indennizzi ora, oltre la terza generazione dopo i fatti, ancora non sono del tutto liquidati. Era la ragion di stato, per la quale spesso le vittime diventano carnefici e viceversa. Tito era diventato il capo dei paesi non allineati, utile nella politica mondiale, e l’Italia aveva il più forte partito comunista dell’Occidente, motivi per cui la strada della verità era preclusa. Il 2 ottobre 1969 il maresciallo Tito fu insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce ordine al merito della Repubblica Italiana. Un’oscenità che ancora esiste. Il 10 novembre 1975 fu sottoscritto il Trattato di Osimo, con cui l’Italia si confermò matrigna cedendo senza ragione o contropartita la sua sovranità territoriale sull’ultimo pezzettino dell’Istria che fu italiana. La zona B del mai nato Territorio Libero di Trieste, dalle alture sopra Muggia alla foce del fiume Quieto vicino a Cittanova. Ad oggi qualcosa è stato fatto per squarciare la coltre di oblio sulla storia contemporanea di Istria, Fiume e Dalmazia, territori già italiani. E molto s’ha da fare, specialmente sui libri di testo. Ma bisogna concludere col dire, in un impeto di speranza, che l’istituzione per legge del Giorno del Ricordo dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata che si celebra ogni anno il 10 febbraio dal 2004, è un enorme passo verso la verità e la giustizia.