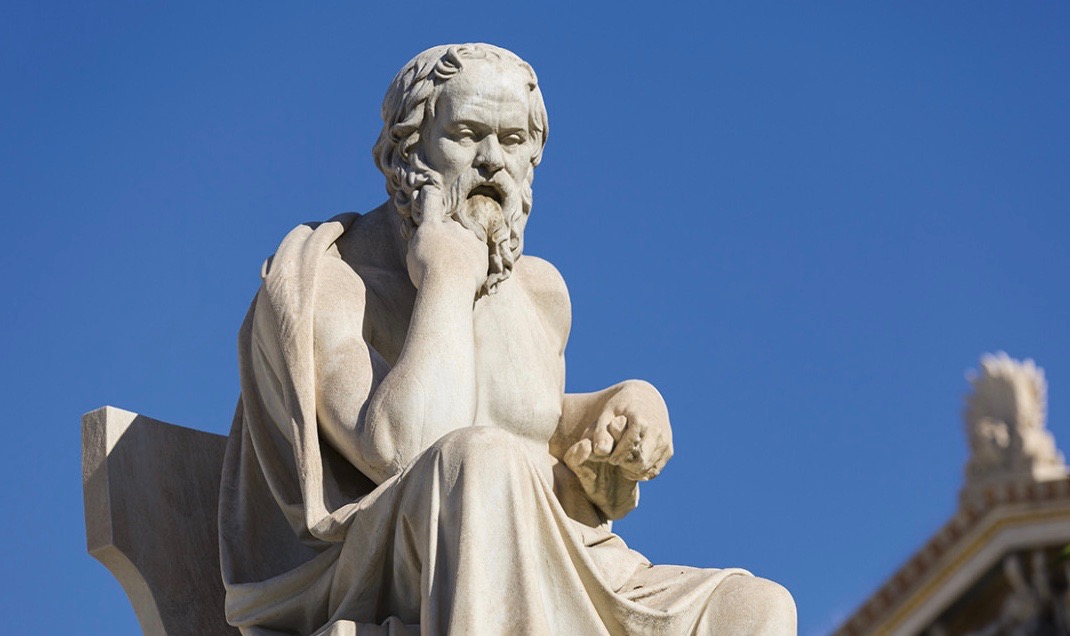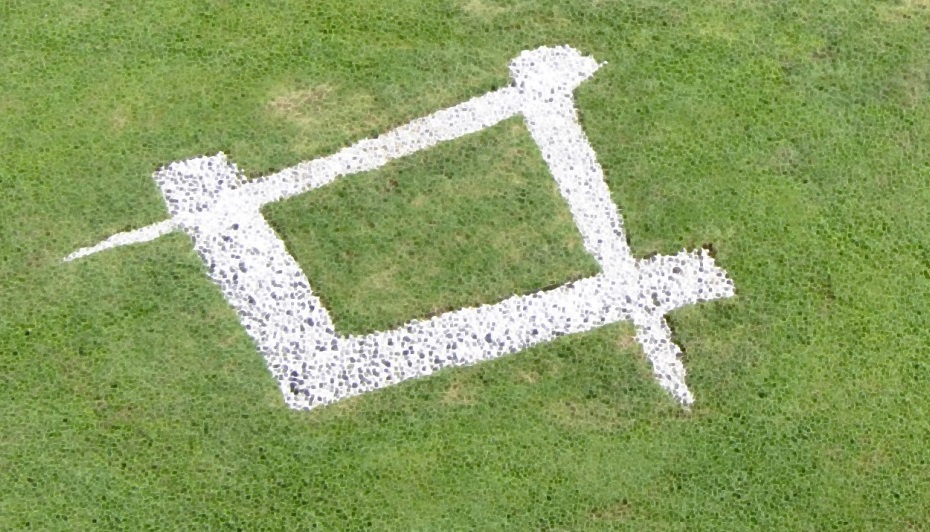Socrate e il male: antidoto allo gnosticismo moderno
–
CI BASTEREBBE FORSE DELLA CONOSCENZA PER SFUGGIRE AL MALE?
Spesso si dice o tacitamente si presume che la filosofia classica in generale insegni che il male altri non è che ignoranza (1); come se bastasse vedere le cose quali sono in sé stesse per sfuggire all’illusione del male o al male come illusione—espressione d’ignoranza, appunto. Cosa si intende però per ignoranza? Ci basterebbe forse della conoscenza per sfuggire al male, o per non essere malvagi? Qual è la fonte della nostra ignoranza? (2) Il bene sarebbe forse identico alla conoscenza, ossia ad una scienza acquisita, per quanto intimamente? Ammettiamo ipoteticamente la possibilità di giungere alla piena conoscenza del bene. Nella misura in cui tutto ciò che possiamo acquisire lo possiamo anche perdere, la paura della perdita della conoscenza non accompagnerebbe naturalmente ogni acquisizione di conoscenza, guastando così la prospettiva di sfuggire al male attraverso la conoscenza? La paura di perdere la conoscenza potrebbe forse spingerci al male malgrado la nostra conoscenza, ma anche a causa di essa? Più sappiamo e più potremmo temere di perdere la nostra conoscenza, essendo quindi spinti dalla paura a fare il male.
Esiste una conoscenza che non possiamo perdere? Una tale conoscenza non sarebbe un’acquisizione, ma una proprietà essenziale del nostro essere (per quanto si accetti l’assunto hegeliano che l’essere supremo ed imperituro sia il prodotto storico-finale del divenire). Ma non possiamo, in un certo senso, perdere il nostro essere? Possiamo alienarci da ciò che siamo originariamente o fondamentalmente? Siamo suscettibili di cadere in uno stato di alienazione dall’essere che è il bene che ci è più proprio?
Platone ci racconta che Socrate aveva bisogno di un daimon, un segno divino che lo fermasse provvidenzialmente prima di compiere il male. Socrate, paradigma di nobile ignoranza, non si affidava gnosticamente alla sua conoscenza per sfuggire al male. Si affidava invece ad un intervento divino. Il martire ateniese suggeriva di conoscere il proprio desiderio, ma allo stesso tempo riponeva la conoscenza delle cose stesse in un dio invisibile. Solo gli dei sono realmente saggi.
L’uomo è forse un dio caduto in uno stato di ignoranza che nessuna conoscenza acquisita può superare? In effetti, l’acquisizione della conoscenza potrebbe servire da maschera del male; un modo per “l’uomo caduto” di nascondere la sua condizione fin troppo umana (la prima “caduta” di Adamo è implicita nel suo primo errore). La “conoscenza originale” stessa – la conoscenza che, come Platone immagina o ci aiuta ad immaginare, l’anima “dimentica” dopo essere stata bagnata nel Lete – non può spiegare il male. Perché saremmo “caduti” in primo luogo? Cosa ci avrebbe spinti a cadere?
Ammettiamo che abbiamo bisogno della conoscenza per sfuggire al male. La conoscenza tuttavia non sarebbe sufficiente. Noi, non meno di Socrate, avremmo bisogno di qualcosa di più della semplice conoscenza per sfuggire al male. Avremmo bisogno di entrambi conoscenza ed intervento divino.
Si consideri l’Alcibiade primo, 118a-c di Platone, dove l’ignoranza della vacuità della nostra presunta conoscenza è causa di svariati mali; non la causa del male in quanto tale. Il problema qui è che la stragrande maggioranza delle persone non è come Socrate, il quale riconosce la propria ignoranza, permettendosi così di sfuggire al male. Egli infatti si lascia guidare da un dio quale sede propria della conoscenza; non da altri uomini, come se costoro potessero trasmettergli la conoscenza necessaria per sfuggire al male (117e, 118e), così come potrebbero insegnarci la virtù.
Il Gorgia 469c4–7 di Platone ci è di ulteriore aiuto, dal momento che il testo evidenzia una discrepanza tra il fare ciò che ci piace ed il fare ciò che vogliamo consapevolmente. La maggior parte delle persone che credono di essere libere in realtà fanno semplicemente ciò che gli fa piacere. Non sanno perché fanno ciò che fanno mentre lo fanno; la loro conoscenza non è tutt’uno con la loro azione. (3) Solo in un dio, o meglio in una mente disincarnata, la conoscenza potrebbe coincidere con l’azione. Noi stessi sappiamo ciò che facciamo solo in preparazione all’azione e in retrospettiva; ma nell’agire stesso siamo, nella migliore delle ipotesi, testimoni o spettatori. La nostra conoscenza non determina le nostre azioni nella realtà. Ciò che ci piace non coincide mai esattamente con ciò che desideriamo. In altre parole, ciò che vogliamo e quindi ciò che sappiamo, non è mai risolvibile nel presente. Cerchiamo ciò che è al di là di noi stessi, al di là della nostra condizione presente, di modo che non appena siamo soddisfatti della nostra condizione presente cessiamo di sapere e diveniamo compiacenti, proprio come il tipo di persone che Socrate descrive come sofferenti di “doppia ignoranza” e quindi dell’essere ignari della propria ignoranza.
Chi fa ciò che vuole veramente? Il tiranno può fare ciò che gli fa piacere, essendo schiavo di opinioni ricevute e quindi di certe apparenze, ma non fa ciò che vuole liberamente. Chi allora potrebbe fare ciò che vuole liberamente? Chi è veramente libero? La conoscenza sembrerebbe un ingrediente necessario alla libertà, ma la conoscenza umana richiede un complemento divino. Per sfuggire al male occorrono sia un anelito al bene stesso, sia una data inclinazione ad esso. Dobbiamo essere compiaciuti del bene, oltreché volerlo. Ciò è però possibile solo là dove ciò che vogliamo non è un’acquisizione, ma il fondamento di tutte le acquisizioni; non qualcosa che afferriamo dolorosamente, ma qualcosa che riceviamo con gioia lasciando andare ogni attaccamento (in un certo senso, anche ogni speranza, come in Dante, Purgatorio 3.9), incluso quello alla nostra ignoranza presente. Accettando la nostra ignoranza senza fare lo sforzo di cercare la saggezza, ci chiuderemmo alla possibilità stessa di ricevere l’aiuto divino di cui abbiamo bisogno per sfuggire al male nell’atto di cercare la conoscenza. Il “lasciar andare” deve essere incondizionato, come in Luca 14:33, dove leggiamo: qui non renuntiat omnibus quæ possidet, non potest meus esse discipulus. L’amante della verità “rinuncia a tutto ciò che possiede”. Ciò include tutta la conoscenza acquisita, ma anche l’ignoranza come stato di autocompiacimento. Rinunciare all’ignoranza equivarrà a rinunciare ad una condizione decaduta, implicando così un’apertura radicale alla morte.
Socrate si riferisce alla filosofia come preparazione alla morte. La filosofia è, per essere più precisi, un dimorare radicalmente esposti alla morte, o un restare in piena ricettività rispetto all’aldilà. (4) Questa ricettività fedele non è un’alternativa alla conoscenza, ma la condizione di possibilità di una conoscenza di cui abbiamo bisogno per sfuggire al male; tenendo sempre presente che la nostra conoscenza da sola non è sufficiente a salvarci dal male. Ciò di cui avremmo bisogno è sia la conoscenza che la guida divina, per cui la nostra conoscenza ci salverà dal male solo a condizione che sia ricercata naturalmente in accordo con il bene stesso (si ripensi qui alla funzione di Virgilio nella Commedia dantesca). La ricerca della conoscenza dovrà quindi accordarsi con la volontà di un dio, come vediamo nel caso di Socrate. Perseguendo invece la conoscenza come fine a se stessa, o come antidoto autosufficiente contro il male, saremmo condannati a ricadere nel male. Perché, messo da parte il nostro desiderio di conoscenza, nel concreto la conoscenza resta per noi una semplice chimera—vana astrazione compatibilissima con il male, come ci mostrano gli ideatori “intellettuali” dell’olocausto nazista. Né può la nostra conoscenza risolvere in sé il nostro desiderio. Per natura, infatti, desideriamo sempre una conoscenza che non abbiamo, o una conoscenza che appartiene propriamente agli dei che riposano in se stessi senza compiacenza, o per i quali il presente è ricolmo sia di passato che di futuro. Per noi, tuttavia, il presente rimane inesorabilmente vuoto sia del passato che del futuro; di un passato che ci ha già lasciati e di un futuro che ci si deve ancora presentare.
Non la sola conoscenza, dunque, potrà salvarci dal male, ma la conoscenza completata da un intervento divino che guida la nostra ricerca della conoscenza in armonia con il bene stesso. Come ci aiuta a vedere Platone nel suo Menone 77b6-78b2, l’obiettivo e la fonte del nostro desiderio dovrebbero coincidere. I Vangeli stessi ci suggeriscono che l’Alfa e l’Omega della nostra vita comune coincidono in un’unica verità da intendersi come conoscenza viva; non un semplice frutto, ma l’albero stesso o la sorgente della conoscenza. Ma allora, come possiamo garantire il nostro accesso alle condizioni di possibilità della libertà dal male? Evidentemente non possiamo semplicemente scegliere di sfuggire al male. Il nostro stesso volgerci al bene non può essere un atto di volontà autonoma, come lo è secondo i moderni ideologi della libertà. L’“autonomia” della nostra volontà esplode di fronte alla vita così com’è e quindi di fronte alla morte. L’ego cartesiano crolla sotto il peso del mondo. Né il Leviatano tecnologico che l’ego moderno si propone di costruire in collettività – un nuovo mondo che converta l’alienazione dalla natura in una virtù (con la pretesa di integrare la natura in sé) – salverà i suoi servitori dall’illusione delirante insita nel confondere la maschera del male con un rimedio al male.
Nel Menone di Platone, Socrate ci invita a vedere la conoscenza, non come una soluzione al problema del male, ma come un contributo necessario ad una soluzione comportante soprattutto, come abbiamo già visto, una chiamata divina. (5) Siamo nati essenzialmente per desiderare la coincidenza di conoscenza ed essere – di conoscenza e vita – che costituisce la fonte stessa del nostro desiderio. In altre parole, siamo originariamente ricondotti ad una conoscenza vivente che non è altro che mente o pensiero (la mens latina designa entrambi) come verità sia della conoscenza che della vita, sia dell’essenza che dell’esistenza. Non “la mia mente”, ma la mente o il pensiero in sé e per sé: ciò che Aristotele chiamerà Dio.
Quando nel Protagora di Platone (345 d6–e4 e 358c6-d4) leggiamo dell’antica visione secondo cui le persone fanno il male contro la propria volontà (ἄκοντες ποιοῦσιν), non dobbiamo concludere che sia sufficiente sapere cosa è bene per fare ciò che è bene. (6) Come ci ricorda San Paolo, la sola conoscenza del bene non ci libera dalla soggezione alla “legge della carne” o alla nostra mortalità (implicante ciò che nel Protagora 356d viene chiamato “il potere dell’apparenza” – ἡ τοῦ φαινομένου δύναμις – in contrapposizione con “l’arte della misurazione” – ἡ μετρητικὴ τέχνη). Il problema qui è che non riusciamo a fare ciò che vogliamo, comportandoci piuttosto contro “la legge della mente” (ὁ νόμος τοῦ νοός – Romani 7,23). (7) Perché non riusciamo (sempre) a fare ciò che sappiamo essere bene? La ragione è da ritrovarsi, come ci suggerisce Dante già nel primo Canto dell’Inferno (vv. 1-12), nel nostro “esseri caduti”, come luce spirituale discesa nell’oscurità, se non altro per risorgere da essa. Non avremmo allora piena libertà in questo mondo, ma solo segni di libertà; la promessa di restaurazione e quindi di liberazione finale ultraterrena dal male.
Sappiamo che qualcosa è un bene, ma non conosciamo la cosa in quanto buona, nel senso che non conosciamo le cose dall’interno, ma dall’esterno. La nostra conoscenza non coincide, in altre parole, con la genesi stessa o la vita delle cose – con il loro divenire in quanto bene (bene agli occhi di Dio, per parlare biblicamente). Conosciamo sia in retrospettiva che in anticipazione, ma non semplicemente nel presente. Nel presente siamo necessariamente ignoranti. In altre parole, il presente è il luogo in cui la nostra ignoranza viene messa a nudo.
La buona notizia “socratica” è che lo smascheramento dell’ignoranza è allo stesso tempo esposizione alla conoscenza come dono vivente, ancora una volta, non come frutto da cogliere, ma come verità da vivere. Non siamo condannati a fuggire dalla nostra ignoranza per acquisire una conoscenza che garantisca che non faremo alcun male. Piuttosto, siamo naturalmente richiamati alla nostra ignoranza come luogo in cui desideriamo ricevere la conoscenza, non come un’aggiunta alla vita, ma come proprietà della vita stessa. Invece di essere condannati a fare il male contro la nostra volontà, saremmo allora invitati provvidenzialmente a fare il bene secondo una volontà divina.
Nel Protagora di Platone (358), Socrate guida i sofisti, quali insegnanti di un auto-controllo (κρείττω ἑαυτοῦ) identificato con la saggezza (ἢ σοφία), perché si vedano come ministri della “salvezza della [nostra] vita” (ἡ σωτηρία τοῦ βίου). Gli interlocutori di Socrate dovrebbero salvarci da “l’ignoranza” (ἀμαθία), vale a dire dalla mancanza di una padronanza di sé comportante la riduzione del piacere a “misura”. Socrate conduce i suoi interlocutori sofistici a concordare sul fatto che “certamente nessuno persegue liberamente / volontariamente cose malvagie o cose che ritiene malvagie” (οὖν…τὰ κακὰ οὐδεὶς ἑκὼν ἔρχεται οὐδὲ ἐπὶ ἃ οἴεται κακὰ εἶναι), aggiungendo che tale condotta non sembrerebbe insita nella natura umana (ὡς ἔοικεν, ἐν ἀνθρώπου φύσει), cosicché la certezza iniziale del concordato si ritrova furtivamente svalutata.
È a questo punto che Socrate s’imbarca ad esporre una sfida che trascende quella della conoscenza in quanto tale, vale a dire quella di un coraggio che precedentemente Protagora aveva dichiarato essere separato dalla conoscenza. Il rilegare della conoscenza al bene (laddove Socrate presenta il sapere come salvezza dal male) si svela servire da preludio al rilegare del coraggio alla conoscenza (359). Il coraggio o la “virilità” (ἀνδρεία) sono necessari per superare la paura intesa come “aspettativa del male” (προσδοκία κακοῦ—358d). Sarebbe quindi esagerato affermare che solo la conoscenza ci salva dal male. Ciò di cui abbiamo bisogno è un connubio tra “conoscenza della misura” e coraggio di fronte al male, un coraggio rivolto ad un bene che sia nel contempo onorevole e piacevole (360a). Nella misura in cui le apparenze sono state ricondotte “misuratamente” al bene in quanto tale, il coraggio può ora aiutarci a trascendere non solo l’apparenza del male, ma il male stesso, trascendendone la spaventosa aspettativa.
Avendo ridotto le apparenze dell’esperienza sensibile a certezze nominali, il sofista ha involontariamente posto le basi per l’ascesa del coraggio come chiave di volta de lla nostra salvezza concreta (360d-e). Possiamo essere davvero coraggiosi, adesso, nella misura in cui vediamo le apparenze alla luce di un unico bene. Non siamo più confusi dalle nostre passioni, perché tutte sono “misurate” e quindi ricondotte ad un bene unico, per cui il piacere non è più visto come una distrazione da ciò che è onorevole o onesto.
L’elevazione o riduzione “scientifica” (nominale/matematica) del piacere al nostro bene comune consente a Socrate di reintrodurre il coraggio/virismo come contenuto vitale della conoscenza, o come conoscenza del male e quindi della concreta disparità tra la conoscenza presunta o nominale dei sofisti e la nostra condizione esistenziale.
Protagora non è più nella posizione di insinuare che il coraggio sia una forma di illusione, o una forza separata dalla conoscenza e dalla verità. È stato portato ad ammettere, piuttosto, che il nostro spirito virile è ingrediente imprescindibile della nostra salvezza, ragion per cui la conoscenza impartita dal sofista non può essere giustificatamente autonoma.
Il discorso di Socrate testimonia la volontà (βουλόμενος) di Socrate di esaminare (σκέπτομαι) la virtù (ἡ ἀρετή) in sé e in relazione ad altre cose, conoscendone le molteplici guise (360e). Potrebbe Socrate aver fatto del male contro la sua volontà? Partendo dal presupposto che non si sbaglia mai volontariamente, il sofista è costretto ad ammettere la bontà dell’esame di Socrate e quindi la giustizia della sua conclusione secondo cui la sola conoscenza del sofista non è affatto sufficiente a salvare la nostra vita dal male in termini concreti. D’altro canto, l’elevazione socratica della giustizia, della prudenza e del coraggio (ἡ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ ἡ ἀνδρεία—361b) allo status di conoscenza (ἐπιστήμη) ha apparentemente aperto la porta alla tesi del sofista secondo cui la virtù può essere insegnata.
Il dialogo platonico si conclude con l’anticipazione di una risoluzione positiva o prometea ad un’apparente confusione di ruoli tra Socrate e il sofista. Socrate infatti non si accontenta di parole concernenti fatti (donde il suo riferimento a Epimeteo), preferendo le parole quali veri e propri veicoli delle azioni. A mere parole e quindi ai sofismi, Socrate preferisce forme appartenenti alla vita stessa.
Fuori del contesto della sua avventura prometea, Socrate avrà parlato solo “come favore al raffinato Callia” (Καλλίᾳ τῷ καλῷ χαριζόμενος—362a), ricco mecenate dei sofisti. Cosa ci si aspetta che abbia imparato il gran signore? Forse nulla di più del fatto che Socrate non mira ad indebolire, ma a perfezionare o completare la conoscenza acquisita in una conoscenza che è propria degli dei.
Epilogo
Platone espone i limiti della sofistica antica (o filosofia pre-socratica) in quanto questa tende a concepire il male in termini strettamente gnoseologici, come un’illusione contenuta nell’anima a prescindere dal divenire generale dell’universo. Per l’anacoreta pre-socratico, la gnosi/conoscenza coinciderà con una tecnica di auto-controllo che ci permette di liberarci dal giogo dell’illusione del mondo, se non dal mondo in quanto illusione stessa. Si potrà cosi sfuggire monasticamente al vortice del divenire (caso e necessità meccanico-materiale) per rivenire all’essere puramente intellegibile (donde nozioni gnostiche di un super-io/ego purgato da ogni ignoranza). A tale proposito Socrate obietterà che nell’ascendere verso la realtà eterna, aldilà di ogni male, il filosofo deve esporsi al suo contesto esistenziale ed in questo senso Socrate si trova in accordo con il moderno. Tuttavia, Socrate si rivolge all’esistenza come ad arena provvidenziale della coltivazione della virtù, piuttosto che come a ciò che i moderni chiameranno “divenire storico” (dove la provvidenza divina lascia il posto ad una logica della Storia, come insegna perentoriamente Hegel). Ne consegue che mentre per Socrate la nostra conoscenza è completata da virtù animate divinamente, per il moderno la nostra conoscenza è completata dalle proprie macchine, o più’ precisamente dalla dominazione tecnologica della natura.
1. Si riveda a questo proposito Eric Voegelin, Il mito del mondo nuovo. Introduzione di Francesco Alberoni. Milano: Rusconi, 1990 [1970].
2. Ammettendo ipoteticamente, non foss’altro che per assurdo, che il solo male sia l’ignoranza, donde proverrebbe quest’ignoranza? Cosa la causerebbe? Da quale male dipenderebbe l’ignoranza stessa? Come ci ricorda S. Agostino, il male non ha causa concreta; non è prodotto o creato da qualsiasi fonte, designando piuttosto l’assenza di causa. Lo stesso non vale necessariamente per l’ignoranza, soprattutto se intesa platonicamente in termini di oblio (lethe), la conoscenza essente allora anamnesis, che includa possibilmente il senso della riconoscenza nostrana. Ignoranza sarebbe allora perdita di conoscenza da ricondursi ad una causa ulteriore. Ma anche ammettendo che l’ignoranza sia assenza primordiale, baratro assoluto di cecità, per cui verrebbe meno un fondamento reale per l’acquisizione di qualsiasi conoscenza (la parzialità presupponendo ontologicamente l’integralità), l’ignoranza costituirebbe un mero aspetto del male, aspetto al quale non sapremmo ricondurre concretamente la codardia ossia mancanza di coraggio, come ci mostra bene Socrate nel Protagora di Platone.
3. Nel Vangelo secondo Luca 23,34, nell’invitare il suo Padre celeste a perdonare coloro che fanno del male (in particolare confondendo il bene e il male) senza sapere quel che stanno facendo, Gesù non riduce il male all’ignoranza, ma conferma che fare del male comporta una disparità tra la volontà ed il fare. Dio ci perdona per aver fatto il male che noi stessi non vogliamo fare liberamente. In questo senso, il padre di Gesù non ci punisce per il male che facciamo, ma ci salva dal male, laddove altrimenti noi ci condanniamo al male nell’atto di cadervi, come vediamo nella “Parabola dei Talenti” in Matteo 25.
4. Sulla “volontà socratica” – la βούλεσθαι del filosofo – come ricettività cognitiva al bene stesso, si veda pp. 10-11 di Hega Segvic, “No One Errs Willingly: The Meaning of Socratic Intellectualism”, citato su https://ancphil.lsa.umich.edu/-/downloads/osap/19-Segvic.pdf (originariamente pubblicato in A Companion to Socrates. A cura di Sara Ahbel-Rappe e Rachana Kamtekar. Malden, Oxford e Carlton: Blackwell Publishing, 2006; pp. 171- 85).
5. Cfr. Platone, Repubblica 505d5-e1 e Cicerone, De Senectute, 5.
6. Vedasi in parallelo il Gorgia 509c6-e7. Il modernista obietterà che tra il sapere e il fare si trovano mere “forze materiali” che la volontà umana può dominare ex machina, escogitando ed implementando un metodo efficiente, forse anche un metodo che si vede “giustificato” dal silenzio della natura nei suoi confronti. A questa obiezione “machiavellico-kantiana” si risponda che, lungi dal permetterci di risolvere i nostri problemi, la tecnologia ne mette in risalto l’ineluttabilità al prezzo di farla apparire assurda, ossia opaca ad ogni intendimento. Infatti, la coincidentia tecnologica di sapere e fare (implicante la potenza della tecnica come veicolo assoluto della felicità) implica la riduzione del sapere a conoscenza tecnica, dirigendoci verso una “soluzione finale” comportante l’annientamento della nostra umanità, quanto meno rispetto a tutto ciò che nell’uomo e dell’uomo trascende la tecnica. Evidentemente, qui la soluzione si svela essere un problema non solo irrisolvibile, ma primordialmente inimico all’umano.
7. Interpretando il Protagora 352d4–7, Hega Segvic (op. cit., 22-24) non giunge ad apprezzare quella che potremmo definire una “lettura paolina” di Socrate per la quale l’ateniese non dice che non facciamo ciò che sappiamo essere male, ma semplicemente che non vogliamo fare ciò che è male, a prescindere dal nostro agire effettivo. Pur evidenziando il richiamo socratico ad un legame impopolare della nostra volontà con la conoscenza (per cui non vorremmo mai fare ciò che sappiamo essere male), Segvic non sembra rendersi conto che, nonostante la nostra conoscenza, spesso ci comportiamo in opposizione al nostro libero arbitrio. Nessuna quantità di mera conoscenza o di stoico autocontrollo può salvarci da tale condizione deprecabile, ma una conoscenza sostenuta divinamente. La potenza soterica de “l’arte della misurazione” e della sua conoscenza (ἐπιστήμη) che in Protagora 356e-358a dovrebbe portare l’anima al “dimorare nella verità” (μένουσαν ἐπὶ τῷ ἀληθεῖ), permettendole di supere così l’edonismo plebeo, è ciò che sofisti quali Protagora preparano i giovani a coltivare; non è ciò che Socrate stesso rappresenta.