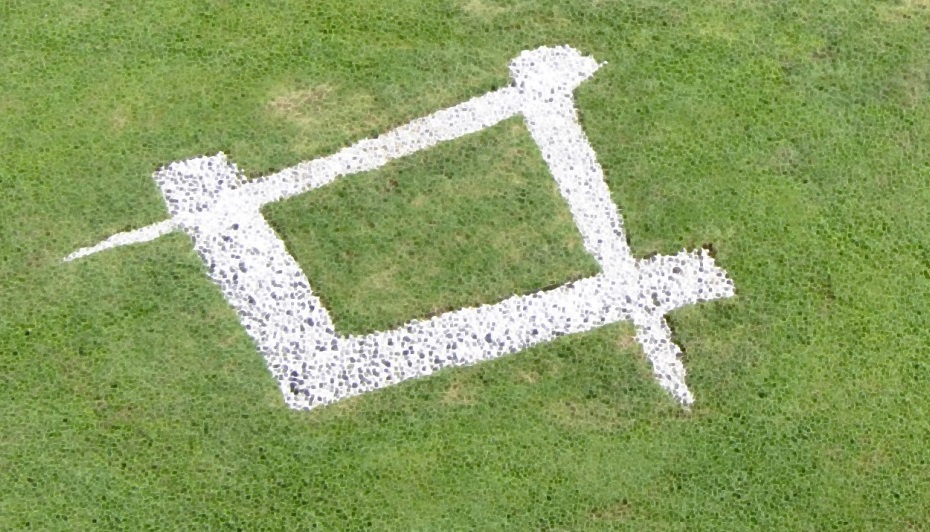La definizione di peccato e il “processo” di conversione continua
LA BIBBIA E IL MAGISTERO DELLA CHIESA INSEGNANO CHE LA MORTE È ENTRATA NEL MONDO A CAUSA DEL PECCATO. ESSO CONSISTE IN UNA PAROLA, IN UN ATTO O IN UN DESIDERIO CONTRARI ALLA LEGGE ETERNA E, ALLO STESSO TEMPO, IN UN’OFFESA A DIO, IN PRATICA NELLA DISOBBEDIENZA AL SUO AMORE. SEBBENE IL PECCATO FERISCA LA NATURA DELL’UOMO E, NELLA SUA PASSIONE, GESÙ NE SVELI PIENAMENTE LA GRAVITÀ, DIO VINCE LA DISOBBEDIENZA E L’INGRATITUDINE UMANA CON LA SUA INFINITA MISERICORDIA. L’APPELLO ALLA CONVERSIONE RISUONA CONTINUAMENTE ANCHE NELLA VITA DEI BATTEZZATI, POICHÉ LA CHIESA È SANTA MA SEMPRE BISOGNOSA DI PURIFICAZIONE
–
Di Sara Deodati
Una definizione di peccato può essere ricavata nel Nuovo Testamento, ad es. in nella prima lettera di Giovanni 5,16-17 che lo identifica in quel rifiuto di Dio che si attua nell’apostasia e nell’idolatria, cioè nel ripudiare la fede nella verità rivelata e nell’equiparare a Dio alle realtà create, erigendole a idoli o falsi dèi. Nel Vangelo di Matteo (12,31s) lo stesso Gesù parla di una «bestemmia contro lo Spirito Santo» che, configurandosi come un rifiuto ostinato di convertirsi, diventa «irremissibile».
Poiché un peccato sia mortale si richiedono tre condizioni:
1) che abbia per oggetto una materia grave,
2) che venga commesso con piena consapevolezza,
3) che sia voluto con deliberato consenso.

Per quanto riguarda la materia grave, essa è precisata dai Dieci comandamenti. Per quanto concerne le altre due condizioni, si tratta di porre in essere una così grave malizia da distruggere la vita di comunione con Dio e operare consapevolmente un atto di ribellione alla Sua volontà.

Mentre il peccato mortale distrugge la carità nel cuore dell’uomo a causa di una violazione grave della legge di Dio, il peccato veniale «non comporta un rifiuto di Dio, ma solo un’incoerenza nel cammino nei confronti di Dio» (Conferenza Episcopale Italiana, La Verità vi farà liberi. Catechismo degli adulti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, n. 929).
Ogni peccato compiuto dal singolo non danneggia soltanto il peccatore, ma ha anche delle conseguenze negative nella comunità ecclesiale e civile. Il vincolo della carità, che unisce Cristo e fra loro le membra del corpo mistico, risulta affievolito a causa di ciascuno dei peccati personali, in quanto il dogma della comunione dei santi comporta l’influsso comunitario dell’agire morale del singolo sia nel bene che nel male.
La rottura radicale con Dio genera nella persona umana un insieme di scissioni che la rende progressivamente sempre più infelice. Il peccatore, in realtà, persegue la gioia, ma poiché la cerca in un posto sbagliato, trova solo tristezza e disperazione. I conflitti dell’uomo all’interno di sé producono sempre nel suo animo un sentimento di disagio, detto “rimorso della coscienza” che, però, può aiutarlo a pentirsi ed espiare la pena dovuta dal peccato solo qualora si accompagni ad una radicale decisione personale in tal senso.
La grande novità dell’annuncio biblico insegna come la realtà del peccato non sia mai definitiva in questa terra, essendo sempre possibile per l’uomo ottenere il perdono di un Dio che è Padre «misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato» (Es 35, 6-7). Dio, infatti, di nessuna cosa tanto si rallegra come della conversione e della salvezza dell’uomo. Quindi la coscienza del peccato, personale o sociale, non dovrebbe mai indurre a un atteggiamento passivo o remissivo ma, al contrario, indurre a quattro convincimenti saldamente radicati nella Rivelazione quali:
– la profondità della misericordia divina;
– la necessità di accettare l’umana debolezza;
– la sovrabbondanza della grazia,
– l’indispensabilità della collaborazione umana al perdono e alla redenzione.
Quando si parla di profondità della misericordia divina s’intende dire che, nessun peccato, per quanto grave o mortale sia, potrà mai estinguere la comprensione e la misericordia di Dio, che è uno degli attributi divini più menzionati nella Sacra Scrittura. Allo stesso tempo, però, il Creatore per accogliere di nuovo nel suo seno gli uomini peccatori deve richiamarli necessariamente a un cammino di conversione e di penitenza.
Di vicende che testimoniano della profondità della misericordia divina è ricco l’Antico Testamento. Ci si può riferire ad esempio ad Elia, il padre dei profeti che, dopo aver imparato la misericordia nel suo ritiro presso il torrente Cherit, insegna alla vedova di Zarepta la fede nella Parola di Dio, fede che egli conferma con la sua preghiera insistente. Grazie ad Elia Dio fa ritornare in vita il figlio della vedova [cfr. 1Re 17,7-24]. Al momento del sacrificio sul monte Carmelo, prova decisiva per la fede del popolo di Dio, «è per la sua supplica che il fuoco del Signore consuma l’olocausto, “all’ora in cui si presenta l’offerta della sera”: “Rispondimi, Signore, rispondimi!” (1Re 18,37) […]. Infine, riprendendo il cammino nel deserto verso il luogo dove il Dio vivo e vero si è rivelato al suo popolo, Elia, come Mosè, entra “in una caverna” finché “passi” la presenza misteriosa di Dio [cfr. 1Re 19,1-14; Es 33,19-23]. Ma è soltanto sul monte della Trasfigurazione che si svelerà colui di cui essi cercano il Volto: [cfr. Lc 9,28-36] la conoscenza della gloria di Dio rifulge sul volto di Cristo crocifisso e risorto [cfr. 2Cor 4,6]» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2583).
È comunque la parabola “del figlio prodigo”, o meglio detta “del padre misericordioso” (Lc 15, 11-24), a mostrare nella maniera più efficace la permanente possibilità dell’uomo di ritornare a Dio dopo il peccato e, al tempo stesso, i caratteri propri di quel “processo” di conversione a lui necessario. La separazione e poi ricongiunzione dell’anima a Dio, infatti, come spiegato nel racconto evangelico, passa ordinariamente sempre attraverso le medesime fasi: dall’abbandono della “casa paterna” a causa del fascino di una libertà illusoria, alla miseria nella quale l’anima si viene a trovare dopo il ripudio dell’amore di Dio, alla riflessione sui beni perduti e, infine, al pentimento e alla decisione di dichiararsi colpevoli davanti al Signore. Solo a questo punto inizia il cammino del ritorno, che trova sempre e inevitabilmente l’accoglienza generosa e la gioia del Padre.

Nel Vangelo di Luca è anche evidenziata una verità confermata sistematicamente dalla storia delle comunità o società che si allontanano da Dio. Il ripudio della Fede da parte degli uomini, infatti, li porta inevitabilmente a non comprendersi più e, quindi, ad allontanarsi gli uni dagli altri (v. Torre di Babele). L’infedeltà a Dio, come insegna la Bibbia, «è sempre alla radice delle divisioni dell’umanità. Ma noi sappiamo che Dio, “ricco di misericordia” (Ef 2,4), come il padre della parabola, non chiude il cuore a nessuno dei suoi figli. Egli li attende, li cerca, li raggiunge là dove il rifiuto della comunione li imprigiona nell’isolamento e nella divisione, li chiama a raccogliersi intorno alla sua mensa, nella gioia della festa del perdono e della riconciliazione. Questa iniziativa di Dio si concretizza e manifesta nell’atto redentivo di Cristo, che si irradia nel mondo mediante il ministero della Chiesa» (Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Reconciliatio et paenitentia, , 2 dicembre 1984, n. 10).
La conclusione della parabola dei “due figli che si allontanano” – questo sarebbe il nome più adatto per il racconto di Lc 15, 11-24 – mostra come la misericordia paterna abbia ristabilito senza remore il figlio minore degenere nella sua condizione filiale. La gratuità del suo donarsi ha permesso al “prodigo” di godere davvero l’eredità, simbolicamente espressa dal banchetto di festa, alla quale si era dapprima privato l’accesso, essendo “morto” mediante il peccato (cfr. Lc 15, 24).

Dalla vicenda del figlio dilapidatore che, allontanandosi dalla casa paterna, si ritrova deluso, affamato e umiliato in un paese “straniero”, risalta anche l’evidenza dell’umana debolezza. Ogni uomo, tuttavia, finché rimane in vita, conserva la capacità di emendarsi una volta sperimentata fino in fondo tutta l’alienazione del peccato. Egli, infatti, come testimonia la parabola, è in grado di rendersi conto che il suo desiderio di “indipendenza” finisce per condurlo all’auto-distruzione, «riducendolo a una condizione quasi animale, tanto da desiderare persino le carrube date ai porci (Lc 15, 16). È proprio l’esperienza della degradazione, insieme al ricordo che nella casa del padre anche i salariati stanno meglio di lui, a determinare il ritorno in sé (Lc 15, 17) del figlio.
Sebbene immerso nella miseria, nell’intimo della sua coscienza, il “figlio prodigo” (e quindi ogni uomo) rimane attirato da una legge che non è lui a darsi, ma «che lo chiama sempre ad amare, a fare il bene e a fuggire il male e, al momento opportuno, risuona nell’intimità del cuore» (Concilio Vaticano II, Costituzione Gaudium et Spes, 7 dicembre 1965, n. 16).
Il peccato, nel contesto della parabola del “figlio prodigo”, significa ulteriormente il venir meno dell’esercizio di quella libertà che il Padre propone, ma che l’uomo rifiuta perché intende praticare una libertà propria, indipendente, che in realtà è riduzione, rimpicciolimento della libertà autentica. Rimanere nella casa del Padre implica rapporti di libertà e di gratuità, ma è proprio questo che in diverso modo nessuno dei due figli capisce. Perché entrambi ragionano in termini di contabilità commerciale o di “pura” giustizia, di rivendicazione o di gelosia. Ma nessun uomo può meritare la grazia prima, cioè quella che sta all’origine della conversione e della giustificazione. Sotto la mozione dello Spirito Santo, anche il peccatore può meritare quelle grazie necessarie per emendarsi, santificarsi e per giungere alla vita eterna. Si parla di sovrabbondanza della grazia, da questo punto di vista, a significare che, l’appello di Cristo alla conversione, continua a risuonare nella vita di ciascun cristiano anche dopo la sua scelta di abbracciare l’amore di Dio. Questa seconda e continua conversione, insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, «è un impegno continuo per tutta la Chiesa che “comprende nel suo seno i peccatori” e che, “santa insieme e sempre bisognosa di purificazione, incessantemente si applica alla penitenza e al suo rinnovamento”. Questo sforzo di conversione non è soltanto un’opera umana. È il dinamismo del “cuore contrito” (Sal 51,19) attirato e mosso dalla grazia a rispondere all’amore misericordioso di Dio che ci ha amati per primo» (n. 1428).
Senza l’aiuto della grazia, nessun uomo saprebbe «“scorgere il sentiero spesso angusto tra la viltà che cede al male e la violenza che, illudendosi di combatterlo, lo aggrava”. È il cammino della carità, cioè dell’amore di Dio e del prossimo. La carità rappresenta il più grande comandamento sociale. Essa rispetta gli altri e i loro diritti. Esige la pratica della giustizia e sola ce ne rende capaci. Essa ispira una vita che si fa dono di sé: “Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde la salverà” (Lc 17,33)» (CCC, n. 1889).
A fianco dell’indispensabile missione riconciliativa della Chiesa, il Magistero ha sempre richiamato l’indispensabilità della collaborazione umana per compiere efficacemente il processo individuale di conversione. Il rimedio principale proposto alla rottura volontaria dell’amicizia con Dio è il sacramento della confessione che, permettendo all’uomo di accedere all’immenso tesoro salvifico della Pasqua, lo porta a considerare, «insieme con le conseguenze sociali del peccato, a quell’aspetto particolare della penitenza che detesta il peccato come offesa di Dio» (Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum concilium, 4 dicembre 1963, n. 109). La via logicamente connessa a questa manifestazione salvifica è senza dubbio quella della penitenza e della preghiera. Riconoscere il proprio peccato, infatti, costituisce «il principio indispensabile del ritorno a Dio. È l’esperienza esemplare di Davide, che dopo “aver fatto male agli occhi del Signore”, rimproverato dal profeta Natan, esclama: “Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato; quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto” (Sal 51,5s). Del resto, Gesù mette sulla bocca e nel cuore del figlio prodigo quelle significative parole: “Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te” (Lc 15,18.21). In realtà, riconciliarsi con Dio suppone e include il distaccarsi con lucidità e determinazione dal peccato, in cui si è caduti. Suppone e include, dunque, il fare penitenza nel senso più completo del termine: pentirsi, manifestare il pentimento, assumere l’atteggiamento concreto del pentito, che è quello di chi si mette sulla via del ritorno al Padre. Questa è una legge generale, che ciascuno deve seguire nella situazione particolare in cui si trova» (Reconciliatio et paenitentia, n. 13).

In conclusione, abbiamo visto come, nella croce gloriosa del Figlio, Dio Padre offre a tutti gli uomini un perdono del tutto gratuito e previo a ogni pentimento (cfr. Lc 23, 34). Questa misericordia divina costituisce l’a-priori della vita cristiana e mostra come Dio sia più grande del peccato. Solo accettando il perdono incondizionato che avviene nella croce di Cristo si può dunque parlare veramente di conversione. È in conclusione il Figlio di Dio, che ha potere sul peccato (cfr. Mc 2, 10), ad aprire la via alla riconciliazione ed al ritorno nella “casa paterna”. In tale percorso di ri-filializzazione è necessario però ritenersi sempre «lontani dalla meta e progredire verso di essa. […] Il progresso consiste nel cercare di evitare ogni peccato mortale e ogni peccato veniale deliberato, e nel fare il bene con motivazioni sempre più pure» (CEI, La Verità vi farà liberi, n. 934).
Riconoscere nelle continue cadute la propria debolezza servirà allora a crescere nell’umiltà, ad essere “misericordiosi” con gli altri e, in definitiva, a confidare in Dio, che ci ama così come siamo.