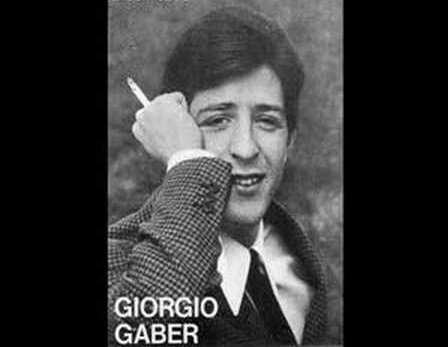Quel contrasto tra la bellezza della santità e la bruttezza dell’odio
IL CANTO DEL MARTIRIO
–
Di Aurelio Porfiri
Sembrerà strano che un musicista come me sia attento all’arte pittorica, ma in realtà dovrebbe essere normale che un musicista sia edotto nella pittura, nella scultura, nella poesia, come dovrebbe essere per un pittore, uno scultore, un poeta e via dicendo. Questi linguaggi si esprimono con molte voci ma il messaggio è unico. Nel caso dell’arte sacra questo messaggio è chiaro e limpido, l’annuncio di salvezza attraverso l’opera salvifica di Nostro Signore poi trasmessa alla sua Chiesa.
Una delle glorie più grandi della Chiesa è quella dei suoi santi, dei suoi martiri. Tra le più note martiri abbiamo santa Cecilia (II-III secolo), martire romana che la Chiesa ricorda il 22 novembre. La giovane martire tentò di convertire il marito Valeriano e il fratello Tiburzio e fu alla fine decapitata, dopo tormenti vari. Cecilia è considerata protettrice dei musicisti, perché sentendo il suono degli organi e di canti nel giorno delle nozze ella nel frattempo cantava a Dio un canto nel suo cuore perché la mantenesse pura.
Il soggetto di santa Cecilia è stato trattato da tantissimi pittori, anche di livello eccelso. Un’opera forse meno nota è quella di Orazio Riminaldi (1593-1630), nativo di Pisa in cui mosse i primi passi alla scuola dei Gentileschi (famiglia di importanti pittori) e dai quali fu poi introdotto agli ambienti romani, che al tempo erano quelli che contavano visto la presenza di numerosi cardinali, della corte pontificia. A Roma fu influenzato dal grandissimo Caravaggio, ma non solo, come ci dice Franco Paliaga: “Nei Ricordi di Ceuli, manoscritti, conservati nell’Archivio dell’Opera del duomo di Pisa, si specificava che il Sansone doveva essere realizzato a Roma, frase che testimonia come Riminaldi risiedesse nella capitale pontificia, dove stava rapidamente emergendo come uno degli artisti di maggior spicco della tendenza caravaggesca, seppur addolcita dai contatti con gli interpreti più straordinari del classicismo emiliano-bolognese (Guido Reni, Giovanni Lanfranco, Domenichino), nonché del realismo di stampo ‘purista’ rappresentato dai francesi (Simon Vouet, Valentin de Boulogne, Nicolas Régnier). Il rapporto con i pittori d’Oltralpe è ulteriormente confermato dalla notizia della sua presenza, in occasione delle festività pasquali del 1624, in casa di Vouet a una riunione insieme ad altri ventidue pittori italiani e stranieri (Bousquet, 1952; Id., 1959)” (Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 87, 2016). Viene considerato il più illustre rappresentante della pittura pisana del diciassettesimo secolo ed è oggetto di vari studi.
Il “martirio di santa Cecilia” (334×216,6 cm.) fu realizzato a Roma, per la chiesa del Pantheon ma ora si può ammirare a palazzo Pitti a Firenze. Questa è la descrizione che ne da Anna Bisceglia: “In quest’opera, databile tra il 1620 e il 1625, Riminaldi dimostra chiaramente di avere assimilato appieno la lezione di Caravaggio persino nella puntuale citazione di alcune sue opere, come il “Martirio di San Matteo”. La teatralità dell’impaginazione scenica, con la sapiente orchestrazione del cono di luce che investe i tre protagonisti, accentua sia la potenza espressiva del carnefice che afferra le chiome di Santa Cecilia per scoprirne il collo e vibrare il colpo di spada, sia il dinamismo dell’angelo che si precipita verso la martire per omaggiarla con i simboli della santità e del martirio. Su questo impianto di stretta osservanza caravaggesca l’artista innesta spunti d’indirizzo decisamente classicista, tratti da Simon Vouet e Guido Reni, ravvisabili nella raffinata mondanità delle sontuose vesti di broccato e nella tenera sensualità della martire. La tela era originariamente destinata alla chiesa di Santa Maria della Rotonda al Pantheon a Roma ma, per ragioni forse legate ad un pagamento non onorato da parte del capitolo della chiesa, fu trattenuta dallo stesso artista che la portò con sé a Pisa nel 1627 e alla sua morte la lasciò ai suoi eredi che la collocarono nella chiesa di Santa Caterina. Nel 1693 fu acquistata dal Gran Principe Ferdinando de’ Medici per la sua raccolta e sistemata negli appartamenti al primo piano di Palazzo Pitti. In quest’occasione la tela fu allargata su tre lati per essere adattata all’imponente cornice di cui è tuttora dotata” (uffizi.it).
In effetti questa descrizione ben identifica l’impianto caravaggesco dell’insieme, quel contrasto violento fra luce ed ombra, con i personaggi che sembrano quasi sbucare dalle tenebre da cui erano stati inghiottiti. L’angelo dall’alto porta la corona, simbolo del martirio e la penna di pavone, simbolo di incorruttibilità: “Secondo credenze narrate già da Plinio il Vecchio, la carne del pavone era incorruttibile ed ogni anno questo rinasceva con nuove splendenti piume. Sant’Agostino (La Città di Dio, XXI,4) testimonia il prodigio delle carni di pavone, a suo vedere voluto dal Cielo: a Cartagine gli fu servito un pavone arrosto (piatto classico dell’antica Roma), e chiese che una parte del petto fosse conservata, per verificare l’effetto del tempo su di esso. Passati molti giorni, mentre altre carni avrebbero avuto cattivo odore, quella del pavone era ancora perfetta, e così ancora un anno dopo. Secondo i principi cristiani il pavone è il simbolo dell’uomo perfetto, giusto e santo, che non è corrotto da alcun vizio poiché, secondo l’opinione degli antichi, la carne del pavone è incorruttibile (Sant’Agostino Gloss. C II Reg.). Come il pavone, che brilla di innumerevoli sfavillii, l’uomo giusto brilla di virtù, e come il canto del pavone mette in fuga i serpenti, l’uomo giusto mette in fuga il demonio con la sua preghiera (Sant’Agostino, De Civitate Deli, Lib.III, c.IV)” (Eugenio Larosa, famaleonis.com).
È interessante il contrasto fra la santa, quasi impassibile nella sua eleganza, mentre è intenta a leggere un libro di musica con il violino posato a terra (allusione al suo patronato musicale) e il carnefice, vestito rozzamente e preso in uno sforzo che sarà teso alla decapitazione di Cecilia. Un contrasto tra la bellezza della santità e la bruttezza dell’odio che mi fa pensare ad una riflessione di Marcello Veneziani: “Il guaio è che la bellezza sta, invece il brutto avanza, si muove, parla, fa. La bellezza è inerte, passiva, inerme, mentre il brutto avanza, incede, si agita. La bellezza è un retaggio, un lignaggio, a volte una rovina, comunque declinata al passato o sperduta nell’antico, mentre la bruttezza è un linguaggio, un modo di fare, di intendere e di volere, tra la tecnica e l’amministrazione. Questa è la nostra tragedia economica e metafisica, estetica e sociale, urbanistica e letteraria. Il bello è, il brutto diviene; il bello posa, il brutto è in moto perpetuo. Il bello attiene alla sfera dell’essere ma non a quella dell’eterno e dell’immutabile. Il brutto, invece, attiene alla sfera del fare e del divenire, ed è virale, espansivo, progressivo” (Lettera agli italiani).
Mi sembra che questo messaggio esca fuori prepotente dal quadro del nostro artista pisano in onore della grande martire romana.