Se una persona giunge a chiedere la morte, cosa vuole veramente?
di Mons. Francesco Cavina*
–
MONS. FRANCESCO CAVINA, VESCOVO EMERITO DI CARPI (MODENA), INTERVIENE SULLA GRANDE DIFFERENZA CHE ESISTE FRA EUTANASIA, ACCANIMENTO TERAPEUTICO E CURE PALLIATIVE. QUESTE ULTIME, DURANTE IL PERIODO DEL “FINE VITA”, SAREBBERO IL PIÙ EFFICACE STRUMENTO PER L’AFFERMAZIONE DELLA CURA DELLA PERSONA E DELLA “CULTURA DELLA VITA”
La vita umana è sempre un bene intangibile e un valore inalienabile, e anche quando la persona giunge a chiedere la morte, occorre domandarsi cosa cela quel grido.
Il 28 febbraio 2014 in Belgio è stata promulgata la legge che approva l’eutanasia per i minorenni, senza limiti di età. In un articolo apparso su un quotidiano belga un genitore ha dichiarato: «I genitori migliori sono quelli che lasciano andare i propri figli». Ma è proprio così!
Esiste una grande differenza tra lasciare andare il figlio e ucciderlo. Il neuro pediatra francese Alain de Broca, fondatore dell’Associazione per la promozione delle cure palliative in pediatria, segue giorno e notte centinaia di bambini con malattie incurabili, fornendo loro cure che tolgono il dolore e permettono loro una qualità della vita altrimenti impossibile. Ebbene, in un’intervista ha dichiarato: «In tutta la mia vita non ho mai sentito un bambino che abbia chiesto di essere lasciato morire perché soffriva troppo». Ed ha aggiunto: «L’eutanasia non è una cura, ma soltanto un termine per mettere fine alla vita dei malati. Di fatto in questo modo si sceglie di rinunciare a occuparci di loro» (Il Sussidiario.net, 4 dicembre 2013).
Se un bambino non ha mai chiesto l’eutanasia, qualcuno deve suggerire loro questa possibilità. Ma è immaginabile un mondo in cui sono i genitori a proporre ai loro figli di morire? I migliori genitori sono quelli che si prendono cura dei loro figli fino alla fine!
È giunto il tempo di ascoltare chi ha vissuto sul campo l’esperienza della prossimità a chi soffre. Tra le personalità più autorevoli e credibili troviamo la straordinaria figura dell’infermiera britannica Cicely Saunders (1918-2005), poi divenuta medico e fondatrice del primo hospice, il St. Cristopher a Londra. Questa straordinaria donna ha posto le basi della nostra moderna terapia del dolore e delle cure palliative. In particolare, la Saunders ha intuito che liberare la persona malata dal dolore e dalla sofferenza significa comprendere che dolore e sofferenza non hanno solo una dimensione fisica, bensì anche emotiva, psicologica, sociale e spirituale. È ciò che lei definisce il dolore totale, davanti al quale ci può essere solo la risposta di un amore totale che si rende presenza.
Il paziente terminale deve anzitutto continuare a vivere la relazione, come elemento costitutivo della sua natura: relazione coi suoi cari, con chi lo assiste e, non da ultimo, deve avere la possibilità di coltivare la sua relazione con Dio. Cicely aveva scoperto che l’indicazione più preziosa per accompagnare la persona nel suo ultimo tragitto terreno è racchiusa nelle parole di Cristo nel Getsemani: Vegliate con me. Scriveva: «Il nostro fondamento più importante per il St. Christopher è la speranza che nel vegliare possiamo imparare non soltanto come rendere i pazienti liberi dal dolore e dalla sofferenza, come capirli e non abbandonarli mai, ma anche come stare in silenzio, come ascoltare, come esserci. Nel comprendere ciò capiamo che il vero lavoro non è affatto nostro» (Vegliate con me, EDB, p. 44). Alla luce di tutto questo pensiamo al dramma di tanti malati che hanno vissuto l’agonia della solitudine e dell’abbandono nei reparti Covid degli ospedali, spesso fino al punto di non poter ricevere il conforto dei sacramenti.
L’esperienza e l’eredità lasciata da Cicely e da tanti altri come lei, ci insegna il vero significato del prendersi cura del paziente, incarnando l’autentica compassione. Concedere il diritto di richiedere l’eutanasia o il suicidio assistito per garantire il rispetto dell’autonomia del singolo, o per regalargli un gesto di “pietà” come spesso si sente dire, o permettergli una “morte degna”, significa aprire le porte ad una cultura disumanizzante che considera il paziente soggetto isolato, esasperandone l’autonomia, staccandolo da ogni relazione di aiuto. Si tratta di quella cultura dello scarto denunciata tante volte da Papa Francesco, la quale si pone in totale antitesi al valore della solidarietà e all’esigenza del vero amore.
La vera solidarietà, infatti, rende solidale col dolore altrui, non sopprime colui del quale non si può sopportare la sofferenza. Il gesto dell’eutanasia appare ancora più incomprensibile perverso se viene richiesto dal coloro che – come i parenti – dovrebbero assistere con pazienza e con amore il loro congiunto o dai medici che per la loro specifica professione, dovrebbero curare il malato anche nelle condizioni terminali più penose (cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Evangelium vitae, 25 marzo 1995, n. 66).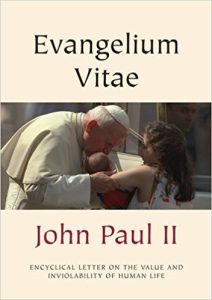
Ma un paziente che giunge a chiedere la morte, in realtà che cosa sta dicendo? Non è forse il suo un grido che va interpretato? Una richiesta di aiuto che deve essere decodificata? L’esperienza della dottoressa Sounders e di molti altri, conferma che «le suppliche dei malati molto gravi, che talvolta invocano la morte, non devono essere intese come espressione di una vera volontà di eutanasia; esse, infatti, sono quasi sempre richieste angosciate di aiuto e di affetto. Oltre le cure mediche, ciò di cui l’ammalato ha bisogno è l’amore, il calore umano e soprannaturale, col quale possono e debbono circondarlo tutti coloro che gli sono vicini, genitori e figli, medici e infermieri» (Congregazione per la Dottrina della Fede, Samaritanus Bonus sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita, cap. V, 2).
In conclusione, chi assiste e si prende cura del malato è chiamato sempre a donare sé stesso in termini di presenza amica, di compagnia forte e benevola, di prossimità umana. Chi ama non lascia solo (“autonomo”) il bisognoso, ma gli rimane accanto condividendo, per quanto gli è possibile, il suo dolore, sostenendo la sua debolezza. Perché solo chi si trova amato, capito e accompagnato nell’ultimo tratto della sua vita, non solo difficilmente giungerà a chiedere l’eutanasia, ma troverà la serenità che solo l’abbandono alle cure dell’amore può dare, diventando lui stesso dono per l’altro.
* Vescovo emerito di Carpi (Modena)




