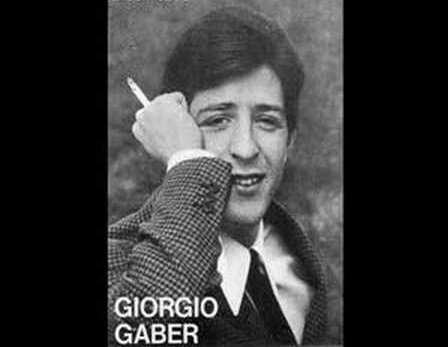Quando il segno di pace è un segnale di inquietudine
di Andrea Ingegneri
–
L’IMPATTO COMUNICATIVO DEI GESTI RELIGIOSI
L’imposizione di restrizioni nella celebrazione della messa in seguito alla proclamazione dello stato emergenziale ha accompagnato le abitudini dei fedeli per un lungo tempo, condizionandole pesantemente. Ciò appare ancor più palese se si considera l’effetto invasivo che queste hanno determinato nelle modalità di approccio all’Eucaristia, dove specifiche prassi di uso della mascherina e la necessità di mantenere il distanziamento hanno introdotto una sorta di liturgia parallela, sommatasi alla proibizione della comunione ricevuta in bocca. Un vero e proprio rituale aggiuntivo che non traeva, tuttavia, legittimazione nella religione ma dalla necessità di aderire a determinati canoni di presunto valore sanitario: le famose “regole” che tutti, in quei tristi e interminabili giorni, abbiamo imparato a conoscere. Senza una scrupolosa e precisa esecuzione di suddette modalità, l’accesso alla Comunione veniva negato.
La teoria della comunicazione ci insegna che qualunque cosa facciamo trasmette un messaggio. I nostri gesti e le nostre azioni sono impregnate di significati, che vengono comunicati agli altri anche in assenza di una deliberata volontà da parte di chi li compie. Tralasciando dunque se vi fosse o no intenzione di trasmettere qualcosa con tale imposizione, non possiamo non prendere atto di come questa nuova ritualità abbia avuto, senz’altro, un impatto comunicativo, e trasmesso un’idea di subordinazione dell’accesso al Sacramento rispetto all’esecuzione del rituale pandemico, il cui primato appare palese.
La possibilità di beneficiare delle Sacre Specie dipendeva, così, dall’esecuzione di un canone parallelo, dove a farla da padrone erano i simboli più rappresentativi del terrore sanitario: la mascherina, l’onnipresente gel, i guanti e il distanziamento. Elementi che parrebbero aver rubato la scena al legittimo protagonista del rituale eucaristico, vale a dire il Cristo, con i suoi significati salvifici ridotti a dettagli secondari. Un dio minore, se paragonato con quello che si poneva come reale padrone di casa di quel frangente: l’impalpabile e compenetrante terrore del virus.
Fatta questa premessa, non dovrebbe risultare strano che tra i fedeli, pur essendo terminata ogni emergenza a livello planetario, e revocata qualunque restrizione dalle stesse autorità che le avevano diramante, si paghino ancora oggi, dopo quattro anni, le conseguenze di questa lacerante ferita, che appare ben lontana dall’essere rimarginata.
Un segno evidente di ciò lo notiamo in quel momento che era il più spensierato nello svolgimento della messa: lo scambio del segno di pace. Finito curiosamente sotto la lente poco prima della questione sanitaria, è divenuto ad oggi occasione di nervosismo tra i celebranti, al punto che qualche sacerdote ha preferito continuare ad agire come se non fosse mai stato ripristinato. C’è chi evade discretamente la chiamata con un cenno del capo, o chi preferisce cimentarsi in un vistoso inchino all’orientale. I più ardimentosi, nostalgici dei tempi in cui il contatto umano era qualcosa di gradito, si cimentano nel difficile compito di strappare qualche stretta di mano ai vicini, con speranzosa insistenza, emulando vagamente quel Don Chisciotte che propendeva l’arma contro i mulini a vento. Fortunatamente, per chi cede e stringe la mano, esiste possibilità di scampo dal presunto contagio mediante abluzione con il gel salvifico, immancabile in ogni tasca o borsetta, e sempre pronto all’uso al momento di accostarsi all’altare, con lo sfregamento compulsivo e il cattivo odore alcolico ormai caratteristici di ogni fine funzione.
Il fenomeno, che ha evidentemente assunto dimensioni grottesche, è divenuto la cartina tornasole di uno stato di inquietudine che ha inquinato la vita religiosa dei fedeli e che trova ancora uno sbocco nel modo di vivere la chiesa. Eppure, pensando al contenuto della 2° lettera di San Giovanni apostolo, verrebbe da chiedersi come questi si sarebbe comportato in un clima simile, e se non avrebbe piuttosto riproposto la sua esortazione “che ci amiamo gli uni gli altri”. Personalmente non penso che un amore virtuale, platonico, fatto di cenni intimoriti a debita distanza, sarebbe stato tra le sue corde. Né ritengo che si sarebbe trovato d’accordo nell’intendere il distanziamento come gesto di amore nell’interesse altrui. Come, infatti, nella stessa lettera precisa poco dopo: “molte cose avrei da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro; spero tuttavia di venire da voi e di poter parlare a viva voce, perché la nostra gioia sia piena”. Forse non è un caso che lo stesso Gesù, vivendo pienamente questa gioia, venisse accusato dai farisei del suo tempo di essere un mangione e un beone. La domanda che dovremmo porci, dunque, è se si possa vivere tale pienezza continuando a navigare nelle torbide acque del terrore, vedendo costantemente nel nostro prossimo una potenziale minaccia fisica da scampare. Soprattutto tenuto conto che già da tempo, per continuare a farlo, non sussiste davvero alcun motivo, reale o presunto. Oppure considerando che molte persone, uscite dalla chiesa, vivono la loro vita con più spontaneità: pranzando tra colleghi, o cenando con amici al pub, stringendo la mano alla presentazione di un nuovo conoscente, ritrovandosi ammassati in metro assieme ad altre centinaia di persone, etc. Fatti, come esperienza quotidiana insegna, vissuti con maggiore spensieratezza.
Cosa succede, allora, dentro le chiese per attivare il Mr. Hide dei tempi bui da terrore pandemico? Cosa può aver trasformato questi luoghi sacri di gioia in deserti dove si rincorrono paure e solitudini senza una precisa ragione e uno scopo? Si direbbe che si attivi una modalità comportamentale condizionata dall’ambiente.
Forse gli stessi pastori, e la Chiesa tutta, dovrebbero prendere il toro per le corna e dare segnali chiari di incoraggiamento al gregge smarrito, invitando i fedeli all’opportuna introspezione per fugare queste nebbie dalle loro anime. Avranno il coraggio di farlo?
Altrimenti, che immagine di Dio si offrirebbe ai fedeli senza invitare a riscoprire la verità di una normalità riabbracciata, scacciando così paura e solitudine? Proprio in virtù dei principi di comunicazione sopra evidenziati, c’è motivo di credere che, senza sostegno della verità, Dio si porrebbe invece come qualcosa di incomprensibile, fuori dai canoni della ragione. Non perché troppo elevato per essere abbracciato dai limiti di una mente umana, ma per la sua difformità da ogni logica razionale intesa dall’uomo. A quel punto la carità stessa avrebbe difficoltà ad essere compresa, col rischio di vedere negli altri delle particelle impazzite soggette alla stessa forza imponderabile. A queste condizioni, amare il prossimo potrebbe pure risultare necessario, ma non avrebbe senso. La solitudine sarebbe dunque l’unica condizione sperimentabile e, di conseguenza, la tristezza. Forse per allontanare questa strana forma di solitudine, più che ad accettare le tristezze di un mondo ostile alla verità bisogna imparare a combattere, e di battaglie da intraprendere nel nome della verità ne abbiamo tante. A cominciare dal riscoprire la pienezza di gioia che nasce dal vivere nel modo autentico il nostro credo, senza strane paranoie.