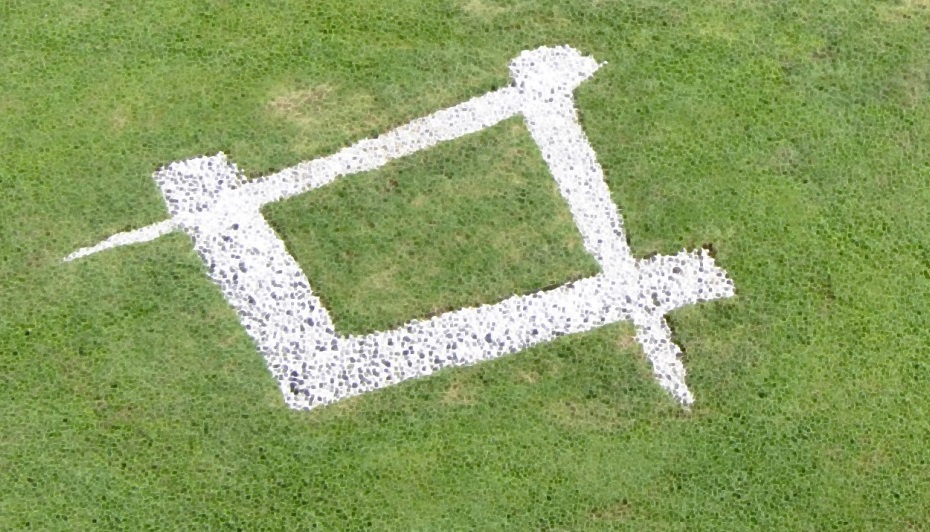Il mostro di Frankenstein riemerge nel contesto della tecnocrazia odierna
di Marco Andreacchio
–
VANGELO E FILOSOFIA: FEDE E RAGIONE NELLA PARABOLA DI GESÙ DEI TRE TALENTI
Dal Vangelo secondo Matteo 25,14–46:
Discedite a me maledicti in ignem æternum, qui paratus est diabolo, et angelis ejus…Et ibunt hi in supplicium æternum, justi autem in vitam æternam.
Introduzione
Uno degli assunti moderni più diffusi in materia di teologia cristiana vuole che la contemplazione risolva o piuttosto dissolva in sé la riflessione filosofica, marcandone la conclusione o incarnandone i limiti in quanto suo terminus ad quem. Eppure nessun’altra formula didattico-morale rappresenta meglio la coscienza medievale che quella della fides quærens intellectum: la fede non essendo un’alternativa all’intendimento razionale, ne caratterizza piuttosto l’alba, esponendoci al fondamento concreto o principio vitale della ragione stessa. Lungi dal chiamarci a risolvere la riflessione filosofica nella fede, o peggio ancora in un sentimento estatico, il cristianesimo canonico antico-medioevale ci richiama alla scintilla o atto provvidenziale divino che costituisce l’alfa e l’omega del desiderio o ricerca naturale di una saggezza intesa come ritorno ai principi delle cose (dove sapientia/scientia è possessione di tali principi).
Là dove la fede costituisce l’apertura originale dell’uomo alla perfezione dell’Essere e dunque all’inerenza primordiale di ogni esperienza in quella perfezione, non ha senso reale sostenere che la fede ponga fine alla ragione filosofica, convertendola in “contemplazione estatica” piuttosto che esporla ai suoi parametri essenziali/naturali e quindi alla coincidentia dell’origine e della fine della riflessione. La fede consisterà nella fiducia spontanea dell’uomo nel senso naturale (e quindi integralità/unità) della ragione—fiducia che 1. vi sia una verità dietro o aldilà di ogni apparenza e che 2. il dubbio umano sia naturalmente ricettivo a tale verità. La fede mostrerà, contro ogni corruzione della ragione naturale, che il desiderio della saggezza denotato dalla ragione filosofica non sia fondamentalmente altro che la scoperta “a ritroso” (anamnetica o archeologica) dei principi delle cose come contenuti della verità quale atto proprio dell’Essere. Le ricerca della verità quindi non implicherà, come lo fa tipicamente in un contesto moderno, l’appropriazione “egoista” di potenza sfidante la morte nello stabilire un nuovo mondo ed una nuova vita fondati sull’autonomia della potenza rispetto ad un fondamento naturale di senso. Donde l’incompatibilità radicale tra cristianesimo e modernità, a prescindere dall’abuso moderno/machiavellico del cristianesimo come cavallo di Troia del suo sovvertimento progressista.
Il Vangelo mette in risalto l’intuizione socratica che la filosofia non sia essenzialmente sofistica, dal momento che l’acquisizione del sapere presuppone la ricezione della verità. La saggezza che Socrate ama spontaneamente non è una potenza conquistata, ma una verità soggiacente ad ogni potenza, una verità intesa come conoscenza vivente o vitale, pianta integrale di ogni conoscenza parziale. Ciò che conta, per Socrate, non è insomma il frutto ma l’albero della saggezza e quindi lo spirito che anima ogni certezza scientifica e a prescindere dal quale ogni scienza risulterebbe morta, tale la poesì che Dante richiamò alla luce nel settimo verso del primo canto del suo Purgatorio.
Nel Vangelo secondo Matteo 25:14-15, Gesù racconta la storia di un anthropos che, partendo da casa o peregrinando in luogo straniero (ἀποδημῶν/peregre proficiscens), offrì (ἔδωκεν da δίδωμι) i suoi averi ai propri tre servi, dando a ciascuno una quantità d’oro proporzionata alla propria “capacità/potenza” (δύναμις/virtus): cinque “talenti” o sacchi d’oro al primo servo, due sacchi al secondo ed uno al terzo. (Da notare qui la ripetizione del termine ἴδιος/proprium, denotante appartenenza stretta.)
Leggiamo che l’uomo, l’anthropos, sia partito immediatamente (εὐθύς) dopo aver ceduto i suoi averi ai suoi servi. Ora, i primi due servi, essendo quelli più capaci, investono il loro oro, raddoppiandone il valore. Il terzo servo, però, parte portando via con sé “il denaro” (τὸ ἀργύριον) scavando nella terra per nasconderlo. Evidentemente, il terzo servo considera il suo dono come denaro e, forse non accidentalmente, per la prima volta l’anthropos del racconto è chiamato esplicitamente padrone (ὁ κύριος/dominus).
Ora, dopo molto tempo (μετὰ δὲ πολὺν χρόνον/post multum vero temporis), il padrone ritorna chiedendo ai suoi servi di dargli un resoconto ragionato (λόγον) di ciò che hanno fatto con il loro oro. I primi due servi risultano fedeli (πιστοί) e sono incaricati non più di poche cose (ἐπὶ ὀλίγα) nel privato, ma di molte cose (ἐπὶ πολλῶν) partecipando alla gioia (χαρά) del padrone.
Essendo stato convocato, il terzo servo si rivolge al suo padrone dichiarando di conoscerlo come “uomo severo” (σκληρὸς…ἄνθρωπος) che si appropria di ciò che non è suo (v. 24). Questa presunta conoscenza fa temere al servo di perdere i suoi averi, spingendolo ad andare a nascondere l’oro sotto terra, apparentemente per poterlo restituire un giorno al suo padrone. Perché i primi due servitori non hanno avuto paura? Forse perché avevano visto l’oro non come denaro da rendere, ma come un dono da investire? Credeva il terzo servitore di investire bene il suo oro nascondendolo “in terra” (γῆν), partendo dal presupposto che il suo padrone alla fine lo avrebbe reclamato “duramente” per sé? Sino a quel fatidico giorno, il servitore avrebbe potuto almeno sentirsi al sicuro, certo che il suo oro era a portata di mano, garantendogli un modico di sicurezza in terra.
Il padrone rimprovera aspramente il terzo servo perché malvagio e “pigro” (ὀκνηρός/piger). Sapendo che il suo padrone mieteva dove non aveva seminato, raccogliendo dove non aveva sparso – temendo quindi che prima o poi avrebbe preso per sé ciò che il servo aveva nascosto in terra – il servo avrebbe dovuto almeno depositare il denaro presso dei “banchieri” (τοῖς τραπεζείταις) per interessi. Non avendo fatto ciò, il servo è ora chiamato ad offrire (ancora una volta il verbo è δίδωμι) la sua unica borsa d’oro (“talento”) al servo che ne ha dieci. Donde la morale esplicita per quanto criptica della parabola: a chiunque ha (τῷ…ἔχοντι παντὶ) sarà offerta l’abbondanza, mentre a chi non ha sarà tolto anche ciò che ha.
Enunciata la sua lezione, il padrone respinge il terzo servo come “inutile” (ἀχρεῖος/inutilis), gettandolo nell’oscurità (in tenebras). Gesù illustra dipoi il contesto metafisico, teologico-politico o propriamente spirituale della parabola (vv. 31-46).
A cosa si riferisce il padrone o dominus della parabola quando parla di “avere”? Che cosa dobbiamo avere affinché ci sia donato in abbondanza e per poter essere elevati alla vita eterna invece di essere maledetti e gettati nel fuoco eterno (εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον/in ignem æternum)? I versi 31-32 ci indicano una risposta adeguata chiamando le nazioni del mondo a mettere ciò che ci è stato donato al servizio degli amanti sinceri della verità, essendo questi i “fratelli e sorelle” del “figlio dell’uomo” (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου) nella sua gloria celeste di re ultraterreno. L’abbondanza che le nazioni riceveranno per il loro servizio ai fratelli dell’uomo divino è un’eredità preparata “fin dalle fondamenta del mondo” (ἀπὸ καταβολῆς κόσμου), cioè un regno divino (Βασιλεία). Servendo coloro che vivono per cose eterne o spirituali, i popoli della terra prenderanno parte al loro regno celeste.
Cos’è allora che dobbiamo “avere” per poter ricevere la salvezza dalla dannazione eterna? Dobbiamo avere ciò che il nostro dominus ci dà da coltivare, cioè il nostro oro o “talento” spirituale. Chi non moltiplica i propri “talenti” – anche solo per paura che “uno” da solo non possa dare frutti – dovrebbe almeno affidarli a chi può, invece di riporre i propri talenti in terra, nascondendo così nell’oscurità lo spirito luminoso.
Originariamente o per natura a tutti noi viene offerto “oro” – ciò che è proprio (ἴδιος/proprium) del nostro signore, cioè la nostra stessa vita, anima o spirito – da coltivare, in modo da poter prendere parte alla gloria del nostro signore celeste. Tuttavia, alcuni tradiscono il nostro mandato comune (si pensi qui al primo verso della Commedia dantesca) seppellendo il loro “oro” nelle attività terrene, invece di prepararsi alla vita eterna. Costoro dovrebbero per lo meno mettere i loro talenti – vale a dire lo spirito o la forma vivente della propria capacità (δύναμις/virtus) – al servizio di coloro che coltivano il loro “oro”. Se, invece, per paura di perdere i nostri averi, li nasconderemo nella “selva oscura” delle certezze terrene, ci condanneremo al supplizio delle tenebre eterne.
Nessuna quantità di guadagno terreno, ossia di potere tangibile, potrà mai renderci la vita eterna. Non importa quanto giustifichiamo i nostri beni terreni come offerte da restituire a un Dio severo; essi beni ci attireranno semplicemente in un abisso di oscurità senza Dio. Solo riconoscendo il nostro “oro” come un dono spirituale da coltivare, non foss’altro che servendo coloro che amano sinceramente la verità, prenderemo parte alla vita eterna e quindi alla luce spirituale di un ordine divino delle cose.
Riflessioni Conclusive: “Il Tempo” tra Vangelo e Modernità
La parabola dei talenti ci invita tangenzialmente a riflettere sul senso del tempo, soprattutto data l’opposizione tra l’immediatezza dell’azione descritta all’inizio della parabola e la distensione temporale suggerita dalla formula μετὰ δὲ πολὺν χρόνον (post multum temporis): “dopo molto tempo”. Alla luce di quanto abbiamo già rilevato, il “molto tempo” indicato da Gesù si svela comportante la totalità della nostra vita terrena. Essendo il dono del Signore null’altro che la nostra vita, la partenza dell’anthropos divino coinciderà con la nostra nascita, mentre il ritorno del Signore coinciderà con la nostra morte, ossia il nostro ritorno alla nostra inerenza nel divino.
Il “raddoppio” del talento offertoci e riferentesi alla coltivazione della virtù – e quindi al riporre del dono nell’atto della donazione – si rivolge all’origine della nostra vita terrena e dunque della distensione temporale. Per l’uomo nella sua essenza divina, il tempo non esiste. Nella misura in cui si trova in Dio, la vita umana sarà concentrata nell’unita dello spirito. La questione del tempo sorgerà solo rispetto al movimento/divenire (δύναμις) della vita, “potenza” che non è in sé terrena, ma spirituale, cosicché sarà bene riconoscere che la parabola dei talenti si riferisce propriamente alla coscienza umana in quanto determinazione dell’atto intellettivo divino. Cosa sarà essenzialmente il “servo” della parabola se non il fratello o la sorella della verità, nel qual termine ritroviamo la rivelazione (ricordiamoci che tale è il senso etimologico di “verità” in greco) dell’Essere?
Il talento che il “servo” è chiamato ad investire altri non è che la coscienza umana chiamata ad “uscire” dal mondo terreno e quindi dall’estensione temporale, scoprendosi interamente spirituale nell’atto dell’investirsi, del darsi quindi in preparazione al ritorno dell’unità della coscienza nella pienezza dell’Essere.
Il buon servo, come la buona ragione (λόγος), è detto fedele visto che risponde al suo mandato, ritornando al proprio principio vitale e dunque all’atto intellettivo che è proprio dell’Essere eterno.
Finalmente vale sottolineare la divergenza radicale del monito evangelico rispetto alla traiettoria della modernità, dato che questa si volge non all’unificazione della coscienza umana nell’atto intellettivo divino, ma alla reificazione della “distensione” della nostra coscienza in una macchina incarnante l’assenza totale di divinità originale o naturale (una divinità misteriosamente o trascendentemente intrinseca nella natura stessa delle cose).
Alla theosis del cristianesimo subentra oggi la singolarità del cyborg, il mostro di Frankenstein riemergente nel contesto della tecnocrazia odierna dove il tempo è unificato, non più naturalmente nell’intuizione razionale, ma virtualmente nella nuova macchina o processo tecnologico, presunto ricettacolo universale di ogni dato (mnemonico) della coscienza. Qui, nella sua auto-determinazione meccanica, il presente pretende includere entrambi il futuro come forma terminale del passato ed il passato, ossia l’estensione della coscienza temporale.
Essente il tempo misura della distanza tra due aspetti di una qualità (p.es., taglia, peso, bellezza o giustizia) considerata dalla coscienza, ossia da un pensiero incarnato, nel nostro contesto tecnocratico dove il divenire non comporta l’unita naturale dell’atto al quale conseguentemente non si rivolge più, trovandosi l’estensione temporale meccanicamente alienata dal presente, il solo nesso concesso tra estensione temporale (cioè il passato) e la sua forma esclude ogni entelechia in favore di manipolazione tirannica del passato e quindi della memoria ora virtualmente svincolata da ogni perché aldilà del factum brutum del dettame tecnologico che vorrebbe infatti incarnare il fine stesso del passato. Ogni desiderio umano dovrebbe essere neutralizzato dall’intervento tecnologico per il quale il futuro stesso non ha alcun senso all’infuori della gestione tecnologica del passato. Occorrerebbe allora “realizzare” il futuro, ossia integrarlo nell’azione della tecnologia governante la totalità della memoria umana.