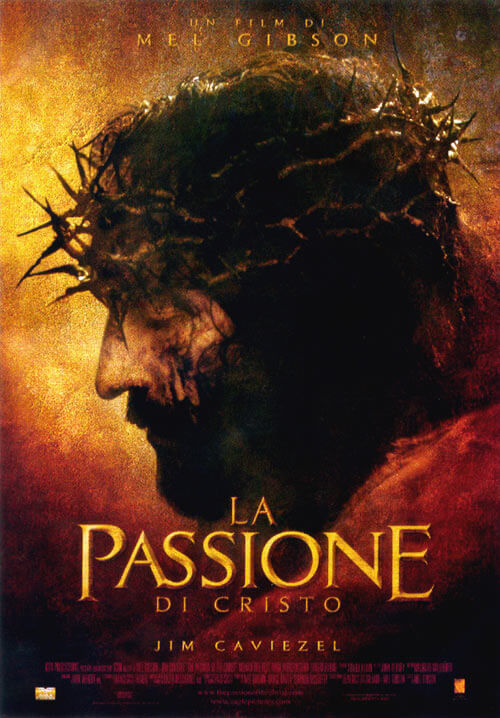Wolfgang Goethe a Girgenti
–
I TEDESCHI E LA SICILIA /1
“Non si può descrivere con parole la luminosità vaporosa che fluttuava intorno alle coste nello stupendo pomeriggio del nostro arrivo a Palermo: la purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle sfumature, l’armonia che univa cielo, mare e terra. Chi li ha visti una sola volta, li possiederà per tutta la vita… spero di potere un giorno, tornato al Nord, rievocare dal mio animo qualche pallida immagine di questa felice dimora… L’aria era mite, tiepida, profumata, il vento molle. Dietro un promontorio si vedeva sorgere la luna che si specchiava nel mare; che dolcissima sensazione… Il Monte Pellegrino, il più bello di tutti i promontori del mondo… L’Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna: è qui che si trova la chiave di tutto”. (Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele: hier ist erst der Schlüssel zu allem)
(Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia – 3 settembre 1786 e il 18 giugno 1788 -, pubblicato nel 1816-1817)
Dopo Federico II Hohenstaufen Re di Sicilia e Imperatore del Sacro Romano Impero (Jesi, 26 dicembre 1194 – Fiorentino di Puglia, 13 dicembre 1250), un altro grande tedesco che amò la Sicilia fu Goethe. Johann Wolfgang Goethe (Francoforte sul Meno, 28 agosto 1749 –Weimar, 22 marzo 1832), uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi e di tutte le nazioni, colui che fu definito “l’ultimo uomo universale a camminare sulla terra” e una delle anime più tragiche e profonde dell’umanità, l’autore di opere immortali come I dolori del giovane Werther, Le affinità elettive e il Faust, giunse in Sicilia con il pittore Christoph Heinrich Kniep, che aveva conosciuto a Napoli, durante un’escursione a Paestum. Con lui conclude un accordo: Kniep farà degli schizzi che poi saranno ceduti al poeta, che comprerà anche alcuni suoi disegni e sosterrà tutte le spese del viaggio.
I disegni e gli schizzi consegneranno ai posteri – oltre il ricordo della memoria visiva – le potenti immagini di una Sicilia omerica, così la vide Goethe, come la “chiave di tutto”. Della Sicilia ama la classicità. Non si cura delle cattedrali arabo-normanne, detesta l’orrido spettacolo del complesso architettonico che il Principe di Palagonia, Ferdinando Francesco II Gravina Cruyllas e Alliata, aveva costruito nei suoi giardini, un museo di statue mostruose, assurde e ripugnanti. Cerca la serena grandezza dell’arte classica, il bello ideale, la nobile semplicità. È quest’ossessiva ricerca della classicità che probabilmente gli impedisce di apprezzare appieno Petrarca e Boccaccio, e persino Dante, mentre familiare gli era Tasso, del quale rielaborava il suo dramma in quei momenti.
Ma soffermiamoci adesso solo sul suo soggiorno agrigentino (ho fra le mani per la terza o quarta volta il suo “Viaggio in Italia” della Mondadori). Il 23 aprile 1787 giunge nell’allora Girgenti da Sciacca dopo una giornata di cammino. Vede le terme, assapora l’acqua salata dall’odore di zolfo, vede il convento sopra la collina. È molto attento alle rocce – i frammenti calcarei, il marmo giallo e la pietra focaia del Platani, il gesso di Montallegro. È affascinato dalla straordinaria posizione di Caltabellotta. “Mai in tutta la vita ci fu dato godere una così splendida visione di primavera come quella di stamattina al levar del sole”.
È affascinato da Agrigento, dalla sua valle spettacolare piena di giardini e vigneti, col suo famoso tempio della Concordia sullo sfondo e i ruderi del tempio di Giunone e degli altri tempi, l’occhio estasiato “digrada rapido verso la pianura costiera a sud, che per un’altra mezz’ora di strada si stende fino alla riva del mare”. Da un “preticello”, lui e Kniep vengono guidati alla visita della città, vedono le vie ben costruite, la cattedrale, ammirano i bassorilievi dei sarcofagi. Nella casa dove abitano, separati da una tenda dalle stanze dei padroni, vedono preparare dalle dita sottili di alcune fanciulle dei maccheroni di “grano forte” a forma di chiocciole che, squisiti e prelibati, poi gustano e mangiano per la prima volta.
Ad Agrigento, Goethe resta quattro giorni e, pur criticando la fretta della guida, ha modo di apprezzare la bellezza del posto che Kniep disegna con scrupolo. Questi disegna un tempio di Giunone in rovina su un dosso rupestre in disfacimento, mentre Goethe ricostruisce con la mente la linea immaginaria delle mura dietro le quali i templi erano stati costruiti. Ammira la linea snella e la bellezza del tempio della Concordia che ha resistito ai secoli, ma deplora la mancanza di gusto – l’utilizzo del gesso bianco, per esempio – dei tentativi eseguiti per conservare il tempio e gli altri monumenti. Misura il triglifo – più di due braccia aperte – del colossale tempio di Giove che si distendeva come un gigantesco scheletro, un cumulo di macerie. Ammira e fa disegnare da Kniep gli altri templi e monumenti, il tempio di Ercole, che lasciava ancora “scorgere tracce dell’antica simmetria”, il tempio di Esculapio, “ombreggiato da un bellissimo carrubo”, la tomba di Terone, gli avelli dei cittadini benemeriti nelle rocce e nelle massicce mura della città.
Goethe è attentissimo anche ai metodi di coltivazione. Parla del modo di piantare le fave, di fare il sapone, bruciando i gambi delle fave e i gusci delle mandorle, e dell’ordine di avvicendamento delle colture, fagioli, grano, tumenia. Tumenia. Un grano estivo, meraviglioso, che matura in tre mesi. “Un grano che non abbisogna di pioggia abbondante, ma di un forte caldo”. “La semina del grano avviene in ottobre e novembre, e a giugno è maturo”. Insomma, una precisione “contadina”, anche se a noi può sembrare elementare. Goethe parla del lino e delle “superbe foglie dell’acanto”, della lupinella che cresce sulle colline non coltivate, dell’avena, dei cavoli, dei fichi, dei mandorli e dell’uva da tavola, dei carciofi e dei broccoli di rapa crudi. Osserva che la terra di Sicilia non è molto ricca di uccelli, vede solo quaglie e uccelli di passo, usignoli, allodole, rondini, di rinnine e ridenne.
Goethe è un osservatore molto attento, un uomo che ha interessi vastissimi. Fa osservazioni di grande acutezza in architettura, in pittura, che destano la meraviglia anche a specialisti moderni. Si occupa anche di mineralogia, botanica, meteorologia, agricoltura. Raccoglie pietre, ceneri vulcaniche, lapilli. È affascinato da specie vegetali che possono crescere solo nel clima temperato dell’Italia – mandorli, ulivi, viti, il tripudio dei colori di Sicilia, e poi il lentisco e il biancospino, l’aloe e il trifoglio, il rododendro, la borragine, gli agliacei. E naturalmente i limoni, gli aranci. Si fa condurre dalla guida nei dintorni di Girgenti, chissà, forse – mi piace pensarlo – sarà entrato nel territorio di Palma, ma non ha lasciato alcuna testimonianza di questa sua possibile escursione. La permanenza in Sicilia durerà quaranta giorni, ma questo viaggio lo scriverà quasi trent’anni dopo, tra il 1813 e il 1817, e molti appunti li aveva già bruciati, il grande tedesco.